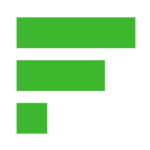Riferimenti normativi
Articoli 633 e ss. del Codice Civile
La legge sancisce che le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva.
Anche in ambito testamentario pertanto è consentito all’autonomia privata di apporre elementi accidentali (condizione, termine e, secondo alcuni, onere).
Il testatore può manifestare, accanto alla volontà diretta soltanto agli effetti tipici del testamento, una volontà alla quale inseriscono elementi che hanno la funzione di incidere in vario modo sugli effetti del medesimo testamento.
La condizione testamentaria presenta, almeno in linea di massima, la stessa disciplina prevista per la condizione in ambito contrattuale.
Essa rappresenta l’elemento futuro è incerto da cui dipende inizio dell’efficacia (Condizione sospensiva) o la fine dell’efficacia (Condizione risolutiva) del testamento.
L’evento dedotto in condizione deve essere futuro rispetto al momento dell’apertura della successione.
Giurisprudenza
La giurisprudenza ha osservato che la futurità deve essere valutata con riferimento al momento della redazione del testamento.
Si è pertanto ritenuta valida la disposizione con la quale il testatore istituisce erede taluno a condizione che lo assista fino alla morte.
L’incertezza dell’avvenimento, che distingue la condizione dal termine, va intesa in senso oggettivo: l’incertezza soggettiva del testatore, il quale ignora che l’evento si è già verificato, è irrilevante.
Qualora manchi lo stato di incertezza, che caratterizza la disposizione condizionata, si è in presenza di una mera raccomandazione o di un termine.
In ambito testamentario l’ambito di applicazione della condizione è soggetto a due limiti:
1 – limite relativo alla quota disponibile, come risulta dal divieto di apporre pesi o condizioni sulle quote spettanti ai legittimari.
2 – limite relativo alle condizioni impossibili o illecite che si considerano non apposte.
Classificazioni
Anche nel testamento, come negli atti inter vivos, la condizione, con riferimento all’evento dedotto, si distingue in potestativa, casuale e mista.
La condizione potestativa si verifica quando la disposizione testamentaria è subordinata al verificarsi dell’evento che dipende dalla volontà dell’istituito.
È nulla anche per il testamento soltanto la disposizione sottoposta condizione sospensiva meramente potestativa.
È, invece, valida condizione risolutiva meramente potestativa, essendo essa un’espressa enunciazione della facoltà di revoca.
La condizione casuale si ha quando l’istituzione subordinata al verificarsi di un evento indipendente dalla volontà dell’istituito, che può dipendere dal caso ovvero dal fatto del terzo.
La condizione mista si ha quando l’evento dipende in parte dalla volontà del testatore e in parte dal caso o dalla volontà di un terzo.
Anche in caso di condizione testamentaria, in pendenza della stessa si verifica una situazione di aspettativa.
L’aspettativa può essere oggetto di trasferimento. In tale caso, che ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.
Esempio
Paolo fa testamento pubblico dal notaio Romani.
Decidere di istituire erede l’amico Andrea, a condizione sospensiva che accudisca il suo cane Argo per tutta la vita.