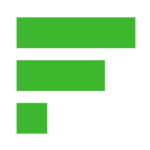Riferimenti normativi
Articoli 14–42 bis del Codice Civile
dal D.Lgs 117/2017 “Codice del Terzo Settore”
dal D.Lgs 112/2017 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”
Disciplina
La fondazione è un’organizzazione non lucrativa che viene costituita per la gestione di un patrimonio finalizzato a un preciso scopo di utilità sociale.
Con riferimento alle modalità operative, vi sono essenzialmente due tipi di fondazione:
– la fondazione operativa (operating foundation) che persegue il suo scopo direttamente, avvalendosi della propria organizzazione;
– la fondazione di erogazione (grantmaking foundation) che persegue il suo scopo indirettamente, finanziando altri soggetti che lo perseguono.
Esistono, più nello specifico, varie tipologie di fondazione:
– di erogazione;
– di famiglia o di impresa;
– di comunità;
– di origine bancaria;
– di partecipazione;
– culturali (tra cui le fondazioni lirico–sinfoniche);
– enti del Terzo Settore.
Le differenze tra un tipo e l’altro risiedono nelle modalità di intervento, nel funzionamento, nel sostegno ad enti esterni o meno, nell’origine fondativa, ecc.
Una fondazione si costituisce per atto pubblico e può nascere anche per volontà testamentaria; in tal caso, sorge solo dopo la morte del fondatore e ha come patrimonio un suo lascito.
Si ritiene, a tal fine, sufficiente anche un testamento olografo (v. Testamento olografo).
La fondazione è creata dalla persona fisica o giuridica (fondatore) che destina il patrimonio allo scopo; i fondatori possono essere più d’uno.
Possono essere fondatori:
- persone fisiche;
- persone giuridiche (società e imprese);
- associazioni;
- enti pubblici.
La costituzione della fondazione avviene mediante la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto, secondo quanto previsto dalla legge.
Nell’atto costitutivo della fondazione, sia esso atto pubblico o testamento, si individuano due atti giuridici distinti, sebbene generalmente uniti nello stesso documento e funzionalmente collegati (sicché la nullità dell’uno si riverbera sull’altro):
– il negozio di fondazione, negozio giuridico non patrimoniale unilaterale (anche in presenza di più fondatori) con il quale il fondatore manifesta la volontà che venga ad esistenza l’ente;
– l’atto di dotazione, negozio giuridico patrimoniale unilaterale con il quale il fondatore attribuisce a tale ente il patrimonio necessario per la realizzazione del suo scopo; nel caso di costituzione con testamento, è un’istituzione di erede o legato.
All’atto costitutivo è normalmente allegato lo statuto della fondazione.
L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione della fondazione, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione ed i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
Possono inoltre contenere le norme relative all’estinzione della fondazione e alla devoluzione del patrimonio nonché quelle relative alla sua trasformazione.
Quanto alla costituzione per testamento, il fondatore di solito si limita ad indicare nell’atto di ultima volontà lo scopo della fondazione, i beni ad essa destinati e, spesso, la sua denominazione, demandando ad un erede o legatario, a carico del quale pone un onere, oppure ad un esecutore testamentario l’effettiva costituzione dell’ente.
In questo caso non sarà il testamento a fungere da atto costitutivo, ma il successivo atto dell’erede, legatario o esecutore testamentario.
L’atto costitutivo può essere revocato dal fondatore prima che sia intervenuto il riconoscimento, salvo che il fondatore abbia fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta. La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
Dopo aver redatto l’atto costitutivo e lo statuto, il passo successivo è quello di rivolgersi ad un notaio perché la fondazione deve essere costituita con un atto pubblico notarile.
Successivamente andrà richiesto il riconoscimento giuridico all’autorità competente, in base alla natura e alla territorialità delle proprie attività.
Ciò significa che se la fondazione opera a livello regionale ed in materie per cui esiste una delega costituzionale alle Regioni, il riconoscimento è regionale.
In tutti gli altri casi spetta alle prefetture, che curano l’apposito registro delle persone giuridiche.
La costituzione di una fondazione è strettamente legata sia al vincolo di destinazione del patrimonio, sia all’entità del patrimonio stesso.
Infatti, le norme vigenti richiedono la presenza di un patrimonio minimo, a seconda dei vari tipi di fondazione.
Per gli enti che operano a livello nazionale il patrimonio minimo va dai 50 mila ai 100 mila euro.
Per gli enti che operano a livello regionale gli importi richiesti sono normalmente minori e a discrezione della Regione.
Per gli enti del Terzo Settore, il Codice del Terzo Settore stabilisce che il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica deve essere:
- 15.000 euro per le associazioni;
- 30.000 euro per le fondazioni.
Nel caso in cui tale patrimonio fosse costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore “deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro”.
Gli organi della fondazione sono:
– il presidente, che di norma è il rappresentante legale;
– il consiglio di amministrazione, che gestisce concretamente la fondazione;
– l’organo di controllo contabile, che verifica tra l’altro anche la corretta tenuta della contabilità e del bilancio;
– l’assemblea (organo facoltativo), il cui ruolo è determinato dallo statuto.
I documenti statutari devono indicare i compiti specifici di ogni organo, nonché le modalità di nomina e di sostituzione dei componenti.
Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione, data l’importanza di questo organo, la legge stabilisce che gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato.
Una eventuale azione di responsabilità contro gli amministratori può essere intrapresa nel caso in cui si ipotizzi l’inadempimento ad un obbligo previsto dalla legge o dallo statuto e il danno conseguito dalla fondazione ne sia conseguenza immediata e diretta.
L’azione contro gli amministratori deve essere autorizzata dall’autorità governativa e attuata dai nuovi amministratori, dal commissario straordinario o dai liquidatori.
Il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni spetta all’autorità governativa, la quale:
– provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi;
– annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume;
– può sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità allo statuto o allo scopo della fondazione o delle norme vigenti.
Unico organo necessario della fondazione è, dunque, l’organo di amministrazione; mancando l’assemblea, prevista invece per le associazioni, si possano concentrare in esso tutti i poteri.
Nel silenzio della legge circa la sua composizione può trattarsi anche di un organo monocratico, sebbene normalmente sia collegiale (variamente denominato: frequentemente consiglio di amministrazione ma negli statuti si trova anche consiglio dei garanti, consiglio direttivo, consiglio di fondazione ecc.).
Lo statuto può stabilire liberamente le modalità di nomina degli amministratori e la loro durata in carica, che può anche essere vitalizia. Spesso il fondatore, se vivente, si riserva il potere di nominare una parte degli amministratori o la presidenza dell’organo amministrativo; va osservato che, se ciò non avviene, il fondatore non è di per sé organo della fondazione.
La nomina degli amministratori, oltre che al fondatore, può essere attribuita a soggetti terzi o allo stesso organo di amministrazione per cooptazione.
Di solito la rappresentanza dell’ente verso l’esterno è attribuita al presidente dell’organo di amministrazione.
In ogni caso le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro delle persone giuridiche, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che ne erano a conoscenza. Sempre al presidente, che può essere affiancato da uno o più vicepresidenti, è solitamente attribuito il compito di curare l’attuazione delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, avvalendosi del personale posto alle sue dipendenze.
Stante la libertà concessa allo statuto in materia di organizzazione, lo stesso può prevedere una pluralità di organi in luogo di un solo organo di amministrazione, adottando, ad esempio, un sistema dualistico di amministrazione, simile a quello delle società per azioni.
Può inoltre affiancare all’organo di amministrazione altri organi, come quello di controllo (di solito denominato collegio dei revisori dei conti, ma in certi statuti è invece previsto un revisore dei conti monocratico) con un ruolo simile al collegio sindacale delle società per azioni, oppure un organo consultivo di esperti nel campo di attività della fondazione (collegio o comitato o consiglio scientifico, culturale ecc.).
La fondazione si caratterizza per l’assenza di finalità lucrative, il che la fa rientrare tra le organizzazioni non a scopo di lucro (o no profit).
Lo scopo della fondazione deve risultare dall’atto costitutivo o dallo statuto.
Con riferimento ad esso si evidenza la tendenza a lasciare la più ampia libertà al fondatore.
I vincoli di destinazione cui viene sottoposto il patrimonio della fondazione (ponendosi in contrasto con i principi di libera circolazione dei beni e di libero sfruttamento delle risorse economiche) si giustificano solo se il patrimonio è destinato ad uno scopo di pubblica utilità, con esclusione, quindi, degli scopi di utilità privata.
Tale limitazione colpisce, in particolare, le fondazioni di famiglia, figura che, peraltro, lo stesso codice civile contempla all’art. 28 dove parla di fondazioni “a vantaggio di una o più famiglie determinate”. Si ritiene che, anche a fronte di questa espressa citazione, le fondazioni di famiglia siano ammissibili nell’ordinamento italiano, a condizione che perseguano comunque scopi di pubblica utilità. Sicché, si ritiene ammissibile una fondazione a beneficio dei soli membri di una determinata famiglia che si trovino in particolari condizioni soggettive di bisogno, meritevolezza (ad esempio, per gli studi compiuti) o simili, non, invece, una fondazione che abbia come beneficiari tutti i membri di una famiglia in quanto tali.
E’ vietata alle fondazioni la distribuzione di utili.
Infatti, argomentando a contrario dall’art. 2247 del codice civile, secondo il quale le società sono contraddistinte dallo scopo di “distribuire gli utili”, si deduce che le persone giuridiche private diverse dalle società – associazioni e, appunto, fondazioni – sono, invece, contraddistinte dal divieto di distribuirli.
La giurisprudenza ritiene che i beneficiari dell’attività della fondazione, se identificabii oggettivamente, abbiano un vero e proprio diritto di credito verso l’ente, assimilando la loro posizione a quella derivante da una promessa al pubblico.
Nell’ordinamento italiano la fondazione acquisisce la personalità giuridica solo con il riconoscimento; in mancanza non dispone di alcuna autonomia patrimoniale, nemmeno imperfetta, a differenza dell’associazione non riconosciuta.
Il riconoscimento è un provvedimento amministrativo adottato, in esito al procedimento disciplinato dal d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361:
– dal dirigente dell’ufficio competente secondo l’organizzazione interna di ciascuna regione o provincia autonoma, per le fondazioni che operano esclusivamente nelle materie rientranti nella competenza legislativa regionale, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola regione o provincia autonoma (art. 14 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
– dal prefetto della provincia in cui è stabilita la sede della fondazione, negli altri casi.
L’ufficio regionale competente o la prefettura-ufficio territoriale del governo verificano che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o regolamento per la costituzione della fondazione, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla sua realizzazione. Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento provvedono al riconoscimento e all’iscrizione della fondazione nel registro delle persone giuridiche da loro tenuto.
Entro lo stesso termine, qualora ravvisino ragioni ostative all’iscrizione o la necessità di integrare la documentazione presentata, ne danno motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi 30 giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell’ulteriore termine di 30 giorni, non viene comunicato ai richiedenti il motivato diniego o non avviene l’iscrizione, questa si intende negata.
Con lo stesso procedimento si procede all’approvazione delle modifiche statutarie e alla loro iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
In questo sono altresì iscritti:
- il trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie,
- la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza,
- la deliberazione di scioglimento e i provvedimenti che lo ordinano o accertano l’estinzione,
- le generalità dei liquidatori e gli altri fatti e atti indicati dalla legge o dal regolamento.
La fondazione si estingue per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto oppure quando il suo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
L’autorità che ha riconosciuto la fondazione – prefetto oppure dirigente della regione o provincia autonoma – accerta, su istanza di qualsiasi interessato o anche d’ufficio, l’esistenza di una delle cause di estinzione e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale territorialmente competente.
A seguito di tale accertamento la fondazione non cessa di esistere ma si apre la fase di liquidazione, durante la quale si procede alla riscossione dei crediti e al pagamento dei debiti residui dell’ente. Alla liquidazione provvedono uno o più liquidatori, nominati secondo quanto stabilito dallo statuto o dall’atto costitutivo oppure, in mancanza di siffatte previsioni, dal presidente del tribunale, che in ogni caso vigila sul loro operato.
Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni dopo che gli è stato comunicato l’atto di accertamento della causa d’estinzione; in caso contrario, sono personalmente e solidalmente responsabili per le obbligazioni assunte.
I beni della fondazione che restano al termine della liquidazione sono trasferiti ad altri soggetti, secondo quanto stabilito dall’atto costitutivo o dallo statuto: è la cosiddetta devoluzione, una successione a titolo particolare.
Se l’atto costitutivo o lo statuto nulla dispongono, i beni sono devoluti ad altri enti che hanno fini analoghi, individuati dall’autorità che ha riconosciuto la fondazione. I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l’anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.
Chiusa la fase di liquidazione, il presidente del tribunale ne dà comunicazione all’autorità che ha riconosciuto la fondazione, la quale provvede alla cancellazione della stessa dal registro delle persone giuridiche, ponendo così fine alla sua esistenza.
Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità oppure il patrimonio è divenuto insufficiente, l’autorità che ha riconosciuto la fondazione, anziché accertare la causa di estinzione, può disporne la trasformazione, che comporta il mutamento dello scopo, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. La trasformazione non può essere disposta quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati dall’atto costitutivo o dallo statuto come causa di estinzione. Non è inoltre consentita per le fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate, norma questa che dimostra un certo disfavore nel legislatore verso le fondazioni di famiglia.