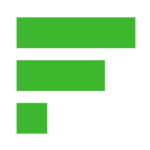Riferimenti normativi
Articoli 2555 e ss. del Codice Civile
L’azienda è un’organizzazione di persone e beni economici, organizzati dall’imprenditore (soggetto che conduce l’attività economica) per l’esercizio dell’attività d’impresa.
Essa è finalizzata alla soddisfazione di bisogni umani attraverso la produzione, la distribuzione o il consumo di beni economici e servizi.
L’azienda, al fine di essere considerata tale, è strutturata in modo organizzato e amministrata in modo funzionale al perseguimento degli obiettivi aziendali.
L’attività aziendale è il complesso delle funzioni aziendali che l’azienda esercita per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, realizzata attraverso processi aziendali, nell’ambito della sua gestione operativa, che seguono un’accurata pianificazione aziendale.
Un’azienda può appartenere a uno qualunque dei settori del sistema economico: settore primario (es. azienda agricola/allevamento), settore secondario (es. industria), settore terziario (ad es. società di servizi).
Le aziende possono essere classificate secondo vari criteri, come, ad esempio in relazione all’attività economica; al fine perseguito; al soggetto economico (ad esempio imprenditore, pubblica amministrazione, ecc.);al soggetto giuridico (società, holding, ecc.); alla dimensione.
In relazione all’attività economica, si hanno:
-
- Aziende di erogazione: fanno parte di questa categoria tutte le aziende come la famiglia, le associazioni private e parte della pubblica amministrazione, che erogano e consumano beni e servizi;
-
- Aziende di produzione: comprende tutte le aziende che acquisiscono e producono beni e servizi (per definizione, si tratta delle imprese);
-
- Aziende composte pubbliche: raggruppa gli appartenenti alle precedenti due classi, come ad esempio lo Stato, la Regione, la Provincia, il Comune, l’Azienda sanitaria locale.
Con riferimento al fine perseguito, si hanno:
- Azienda familiare: persegue il suo scopo tramite valori non economici (come l’assistenza reciproca, i sentimenti, ecc.) ed economici (consumi, investimenti e risparmio). Non va confusa con l’impresa familiare (v. Impresa familiare), cioè l’istituzione economica che impiega membri della stessa famiglia e che è volta a produrre reddito.
- Azienda pubblica: si occupa in primo luogo di soddisfare i bisogni pubblici ed accresce e distribuisce valore non solo in relazione alla collettività; recentemente, si è assistito alla privatizzazione di molte aziende pubbliche (tra le altre: Telecom Italia, INA Assitalia, Comit, Credito Italiano e Alitalia)
- Aziende di produzione: ha come fine principale la produzione e distribuzione di ricchezza e come fine secondario il soddisfacimento dei bisogni umani.
- Aziende non profit: si tratta di aziende che non hanno fini di lucro soggettivo, nel senso che, pur potendo realizzare dei risultati economici e finanziari positivi, questi non vengono distribuiti al soggetto economico. È tuttavia lecito che svolgano una qualche attività commerciale inerente all’oggetto sociale purché essa sia solo marginale o rientri all’interno di finalità di utilità sociale. Un discorso particolare vale per le ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale). Si tratta di una qualifica ai fini delle imposte – ovvero che incide sulle modalità di pagamento delle imposte – che possono assumere le aziende non profit che operano in uno dei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sociale, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela e promozione dei beni storici e artistici, tutela dell’ambiente, promozione culturale e artistica, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica. Tali società devono essere iscritte all’anagrafe delle ONLUS, presso la Direzione Regionale delle Imprese per avere diritto a particolari vantaggi fiscali (non sono soggette a tassazione).
- Aziende mutualistiche: comprendono cooperative, società di mutua assicurazione e consorzi di cooperative. La cooperative hanno uno scopo principalmente mutualistico che consiste nel fornire beni o servizi o lavoro direttamente ai soci, in modo più vantaggioso rispetto alle condizioni del mercato. Lo scopo mutualistico assicura la limitata distribuzione degli utili tra i soci e la devoluzione a scopi di utilità pubblica del patrimonio sociale, in caso dello scioglimento della società. Oltre ai soci ordinari è possibile che ci siano dei soci sovventori che investono nella cooperativa al fine di ottenere un interesse sul capitale investito. Le attività che possono essere svolte in forma cooperativistica comprendono: consumo, produzione, lavoro agricolo, edilizia, trasporti, pesca, economia sociale. Le società di mutua assicurazione sono cooperative che si occupano di attività assicurativa (ramo vita e ramo danni), sono a responsabilità limitata e il capitale sociale è costituito dai contributi versati dai soci, che servono anche come premi assicurativi.
In relazione al soggetto giuridico si distinguono due tipi:
– l’imprenditore con la sua impresa individuale, in cui soggetto economico e soggetto giuridico coincidono;
– le società in cui due o più persone svolgono un’attività economica (e i due soggetti sono distinti).
In proposito occorre ulteriormente distinguere:
- l’impresa individuale, quando il soggetto giuridico è una persona fisica che risponde coi propri beni delle eventuali mancanze aziendali. Tale impresa non gode quindi di autonomia patrimoniale: se viene dichiarata fallita, anche il suo imprenditore è fallito.
- la società di persone, caratterizzata da un’autonomia patrimoniale imperfetta, in cui cioè il patrimonio della società non è perfettamente distinto da quello dei soci, per cui i creditori possono rivalersi (se il patrimonio societario è insufficiente) anche sui beni del socio (solitamente non vale l’inverso).
In tale ambito rientrano:
- la società semplice nel caso in cui non sia necessario svolgere un’attività commerciale, ma si abbia la necessità di gestire un’attività (agricola o professionale, come ad esempio uno studio associato);
- la società in nome collettivo in cui tutti i soci sono responsabili in egual parte e con tutto il loro patrimonio delle obbligazioni della società
- la società in accomandita semplice in cui i soci accomandatari rispondono come nella Società in nome collettivo e i soci accomandanti rispondono invece limitatamente al capitale conferito.
In tutti e tre i casi non si ha l’obbligo di versare un capitale sociale minimo, ma è necessario avere un atto costitutivo e redigere un bilancio d’esercizio (che può non essere depositato al Registro delle Imprese). Le società di capitali sono dei soggetti giuridici totalmente autonomi che godono di autonomia patrimoniale perfetta (il loro patrimonio è distinto da quello dei soci).
Le società di capitali sono:
- società a responsabilità limitata
- società per azioni
- società in accomandita per azioni, dove il socio accomandatario (amministratore) risponde illimitatamente col suo patrimonio delle obbligazioni sociali se il patrimonio della società non è sufficiente. Le società di capitali hanno l’obbligo di versare un capitale sociale minimo e di approvare il bilancio annuale che va depositato presso il Registro delle Imprese.
Tra le altre forme possibili si trovano le associazioni temporanee d’impresa, i consorzi e il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico).
Le aziende non sono solo espressione di imprese private: anche la Pubblica amministrazione dà vita ad aziende (a volte sono ex enti di diritto pubblico), quali società multiservizi, società partecipate, società a capitale misto, ecc.
In relazione alla dimensione, possono distinguersi imprese (di conseguenza, aziende):
- piccola (e micro)
- media
- grande
Tra i molteplici criteri utilizzabili ai fini di tale inquadramento, si può citare:
– fatturato
-numero di dipendenti
– bilancio
– valore aggiunto