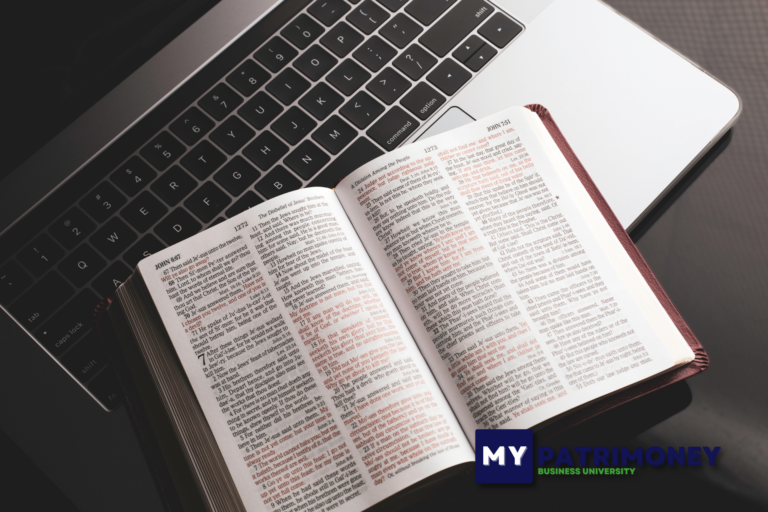(v. Azienda)
(v. Azienda – Segni distintivi)
Riferimenti normativi
Articoli 2569 – 2574 del Codice Civile
Articoli 7 – 28 del codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche).
Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa;
Regolamento n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario;
Regolamento CE 2868/95 della Commissione del 13 dicembre 1995 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE); n. 40/94 sul marchio comunitario (come modificato dal Regolamento n. 355/2009 della Commissione, del 31 marzo 2009).
Regolamento CE 2869/95 della Commissione del 13 dicembre 1995 relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (come modificato dal Regolamento n. 355/2009 della Commissione, del 31 marzo 2009).
Regolamento CE 216/96 della Commissione del 5 febbraio 1996 che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno.
Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883 (come successivamente modificata).
Trattato sul diritto dei marchi, sottoscritto a Ginevra il 27 ottobre 1994.
Il marchio è un segno distintivo, suscettibile di essere rappresentato graficamente, che distingue i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di un’impresa concorrente.
Può estrinsecarsi in disegni, cifre, lettere, colori, forma dei prodotti o delle confezioni, etc. Al marchio nazionale si aggiungono il marchio comunitario e il marchio internazionale. Tutte le relative discipline mirano all’obiettivo unitario di garantire al loro titolare il diritto all’utilizzo esclusivo dello stesso, in un territorio più o meno limitato.
Del marchio possono farsi svariate classificazioni:
- marchio individuale, che si ha quando esso identifica il bene o il servizio oggetto dell’attività di impresa,
- marchio collettivo, che ha la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità dei prodotti o dei servizi offerti (si pensi, ad es., al marchio collettivo “pura lana vergine”).
A seconda del fatto che il marchio sia riferito a un’impresa che produce beni, a una che li commercializza o a una che offre servizi, si può distinguere:
- marchio di fabbrica,
- marchio di commercio,
- marchio di servizio.
In base ai segni che vengono utilizzati come marchi è, inoltre, possibile individuare le seguenti tipologie di marchio: denominativo, figurativo, misto, di forma, olfattivo, di suono, di colore.
Un’ulteriore distinzione che è possibile fare è quella tra marchi generali, che riguardano più prodotti o servizi, e marchi specifici, utilizzati per identificare un solo prodotto o servizio.
Infine è possibile distinguere dai marchi principali quelli difensivi, che sono simili ai primi e vengono registrati per limitare maggiormente gli spazi della contraffazione.
A pena di nullità il marchio deve essere originale, vero, nuovo e lecito.
L’originalità implica che il prodotto o il servizio offerto dall’imprenditore possa essere distinto da tutti gli altri presenti sul mercato, senza che sia possibile utilizzare come marchi la descrizione dei caratteri essenziali del prodotto o del servizio, la loro denominazione generica, i segni di uso comune. Un produttore di automobili, ad esempio, non può utilizzare il marchio “Auto”.
La verità implica che il marchio non debba essere idoneo ad ingannare il pubblico circa la provenienza, la natura o la qualità dei prodotti o servizi offerti dall’impresa.
Secondo il principio di novità, il marchio deve essere differente da altri segni distintivi già di fatto utilizzati in ambito nazionale. A tal proposito è opportuno distinguere tra marchi ordinari e marchi celebri, poiché mentre per i primi è necessario che il marchio non crei confusione con l’attività di imprenditori che siano concorrenti, per i secondi non occorre che le attività con le quali potrebbe sorgere confusione siano in concorrenza, essendo sufficiente, per decretarne la nullità, il fatto che la rinomanza del segno anteriore dia comunque un vantaggio indebito all’imprenditore che lo riproponga per la propria attività (è ad esempio nullo il marchio Ferrari da parte di un produttore di orologi).
Nel rispetto del requisito della liceità, infine, il marchio non deve essere in contrasto con norme imperative, di ordine pubblico o di buon costume.
Il marchio può essere liberamente trasferito dal suo titolare, sia in via definitiva che temporaneamente.
Questa seconda ipotesi si verifica attraverso la cd. licenza di marchio, che può essere sia esclusiva che riferita a più concessionari e lasciare anche la possibilità di utilizzo congiunto da parte del titolare. In questa seconda ipotesi, tuttavia, il marchio deve essere utilizzato per prodotti o servizi con caratteristiche uguali tra loro, a pena di decadenza dal relativo diritto.
In ogni caso il trasferimento del marchio non deve mai ingenerare confusione tra il pubblico circa i caratteri essenziali dei prodotti o dei servizi offerti.
Ciascun imprenditore ha diritto di avvalersi in modo esclusivo del marchio da lui prescelto, al pari di quanto avviene per la ditta e l’insegna.
Il diritto all’uso esclusivo del marchio può acquistarsi in due modi:
– con la registrazione (cd. marchio registrato). Per registrare validamente un marchio nell’ambito del territorio nazionale è necessario depositare l’apposita domanda all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o alle Camere di commercio locali.
Dal 2 febbraio 2015 per le imprese che vogliono accedere alle agevolazioni è possibile trasmettere online, direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico, le domande di brevetto, marchio e disegno industriale.
– con l’uso di fatto (cd. marchio non registrato). A norma dell’art. 2571 c.c., invero, chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso.
Il marchio non registrato gode di una tutela minore di quello registrato: infatti chi ottiene la registrazione gode della presunzione assoluta della titolarità del diritto e di una protezione estesa comunque a tutto il territorio nazionale; colui che vanta soltanto un preuso, invece, deve innanzitutto provarlo e riceve poi una tutela limitata all’ambito entro il quale detto preuso sia avvenuto. L’esclusiva, inoltre, non si estende mai ai prodotti affini a quelli individuati dal marchio di fatto. Nella sola ipotesi di notorietà nazionale, però, il titolare di un marchio di fatto potrà ottenere che sia dichiarato nullo, per difetto del requisito della novità, un marchio confondibile successivamente registrato (cd. marchio notorio): la relativa azione dovrà essere esercitata nel termine di cinque anni dalla registrazione (art. 28 C.P.I.).
Contro chiunque usi il suo marchio contraffatto (a parte la tutela penale) l’imprenditore può esercitare:
– l’azione di usurpazione e di contraffazione, rivolta ad ottenere l’accertamento dell’abusiva riproduzione del marchio identico, ovvero la contraffazione dello stesso e la lesione dei diritti che ne deriva. L’azione di contraffazione può essere preceduta da due misure cautelari: la descrizione, che ha la funzione di precostituire la prova della contraffazione; il sequestro, che ha la funzione di evitare la circolazione dei prodotti la cui presenza sul mercato costituisce violazione dei diritti di marchio (art. 129 C.P.I., modif. dal D.Lgs. 131/2010).
– l’azione di rivendicazione, esperibile in tutti i casi di abusiva registrazione di un marchio da parte di un soggetto che non ne abbia diritto (art. 118 C.P.I.);
– l’azione inibitoria, diretta ad ottenere che l’altro soggetto cessi di usare il marchio contraffatto;
– l’azione di rimozione, diretta ad ottenere la distruzione del marchio contraffatto ed, eventualmente, dei prodotti posti in vendita con tale marchio;
– l’azione di risarcimento del danno derivante dall’uso che altri abbiano fatto del marchio (art. 125 C.P.I.);
– l’azione di concorrenza sleale.
Il marchio, al sopravvenire di determinate circostanze, può estinguersi. Nei fatti ciò accade, in primo luogo, in caso di volgarizzazione, che si ha quando il marchio diviene denominazione comune del prodotto o del servizio e perde, in conseguenza, la propria capacità distintiva.
Si ha estinzione del marchio, poi, per non uso, ovverosia se, salvo motivo legittimo, il suo titolare non lo utilizzi per un periodo ininterrotto di cinque anni.
Il marchio, infine, si estingue per illiceità sopravvenuta.