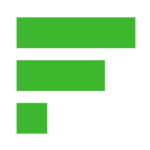(v. anche Azienda)
Segni distintivi dell’impresa sono la ditta, l’insegna ed il marchio che la legge tutela riconoscendone all’imprenditore la esclusività dell’uso e impedendo che altri se ne avvalgano.
Tra i segni distintivi assume una prevalente importanza la ditta (v. Azienda – Ditta), che è il nome sotto il quale l’imprenditore svolge la sua attività.
La ditta può essere trasferita sia per atto tra vivi che per causa di morte purché con essa avvenga contestualmente il trasferimento della azienda.
L’insegna (v. Azienda – Insegna) è il segno distintivo del locale nel quale si svolge l’attività dell’imprenditore. Essa può corrispondere alla ditta e, in questo caso, la tutela dell’insegna è un riflesso della tutela della ditta; può, invece, avere un contenuto diverso ed essere formata sia mediante una denominazione, che mediante figure o simboli.
Anche in questo caso l’insegna deve presentare i caratteri della originalità (e cioè capacità distintiva) e della novità (deve essere, cioè, tale da non ingenerare confusione, in relazione al luogo e all’oggetto dell’attività, con l’insegna adottata da altro imprenditore).
Quanto al marchio ed alle creazioni intellettuali, il marchio è il segno distintivo del prodotto (v. Azienda – Marchio). Esso può consistere tanto in un emblema (cd. marchio emblematico), quanto in una denominazione o in un segno (si pensi al cavallino rampante delle auto della Ferrari), purché presenti carattere distintivo e cioè: abbia il carattere delle novità; non sia contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; non sia generico e non veritiero.
Funzione precipua del marchio è dunque quella di differenziare i prodotti di un imprenditore da quelli merceologicamente similari immessi sul mercato dai concorrenti.
I requisiti di validità del marchio sono:
- la novità: non deve essere già noto come marchio di prodotti o merci dello stesso genere fabbricati o messi in commercio da altri imprenditori;
- la liceità: non deve essere contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
- la verità: non deve ingannare i consumatori circa la qualità, la provenienza e la natura dei prodotti;
- l’originalità: non deve essere generico ma dotato di capacità distintiva.
Ciascun imprenditore ha diritto di avvalersi in modo esclusivo del marchio da lui prescelto, al pari di quanto avviene per la ditta e l’insegna.
Il diritto all’uso esclusivo del marchio può acquistarsi in due modi:
– con la registrazione (cd. marchio registrato). Per registrare validamente un marchio nell’ambito del territorio nazionale è necessario depositare l’apposita domanda all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o alle Camere di commercio locali. Dal 2 febbraio 2015 sono cambiate le modalità di deposito di brevetti, marchi e disegni industriali in Italia. Infatti, per le imprese che vogliono accedere alle agevolazioni è possibile trasmettere online, direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico, le domande di brevetto, marchio e disegno industriale.
– con l’uso di fatto (cd. marchio non registrato).
La legge prevede che chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso.
Il marchio non registrato gode di una tutela minore di quello registrato: infatti chi ottiene la registrazione gode della presunzione assoluta della titolarità del diritto e di una protezione estesa comunque a tutto il territorio nazionale; colui che vanta soltanto un preuso, invece, deve innanzitutto provarlo e riceve poi una tutela limitata all’ambito entro il quale detto preuso sia avvenuto. L’esclusiva, inoltre, non si estende mai ai prodotti affini a quelli individuati dal marchio di fatto. Nella sola ipotesi di notorietà nazionale, però, il titolare di un marchio di fatto potrà ottenere che sia dichiarato nullo, per difetto del requisito della novità, un marchio confondibile successivamente registrato (cd. marchio notorio): la relativa azione dovrà essere esercitata nel termine di cinque anni dalla registrazione (art. 28 C.P.I.).
La legge tutela, inoltre, le creazioni intellettuali e, in particolare:
– le opere dell’ingegno, che sono le idee creative nel campo culturale;
– le invenzioni industriali, che sono le idee creative nel campo della tecnica.
Il sistema normativo è strutturato sul:
– riconoscimento del diritto d’autore per le opere dell’ingegno letterarie e artistiche;
– risconoscimento del diritto di brevetto per le invenzioni industriali, per i modelli di utilità e per i modelli e i disegni.
Le invenzioni industriali sono tutti i nuovi ritrovati e le nuove soluzioni di problemi tecnici che hanno un’attitudine ad essere applicati nell’industria e a dare un immediato risultato produttivo.
Il diritto dell’inventore non sorge automaticamente a seguito dell’invenzione, ma deriva dalla concessione del brevetto da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, concessione che consiste nella registrazione dell’invenzione nel Registro dei brevetti per invenzioni industriali.
I caratteri che l’invenzione deve presentare affinché sia brevettabile sono:
- novità, cioè non essere già compresa nell’insieme delle conoscenze tecniche e non essere stata ancora divulgata;
- originalità, cioè deve essere il frutto di un’attività inventiva;
- liceità, cioè non contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume;
- industrialità, cioè deve essere suscettibile di utilizzo pratico da parte di qualsiasi tipo di industria, anche agricola. Non è quindi brevettabile un’invenzione che ha carattere solo teorico o scientifico in quanto non può essere applicata in un processo produttivo.
Il brevetto per invenzione industriale dura 20 anni dalla data di deposito della domanda (art. 60 C.P.I.); il brevetto per modello di utlità dura 10 anni dalla data di presentazione della domanda (art. 85 C.P.I.).