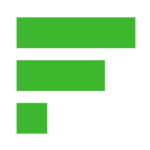(v. anche Residenza familiare)
Riferimenti normativi
Articolo 337 sexies del Codice Civile
La casa familiare o casa coniugale è un concetto che viene in diritto viene richiamato al momento della separazione o del divorzio dei coniugi.
La casa familiare è il luogo di normale e abituale convivenza del nucleo familiare, l’habitat domestico inteso come il fulcro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si svolge e sviluppa la vita della famiglia.
Perché si possa parlare di casa familiare non è necessario che tutti i membri della famiglia abbiano fissato, in tale immobile, la propria residenza (v. Residenza familiare), essendo piuttosto importante un concetto di fatto, quello dell’abitualità dell’utilizzo della stessa per le riunioni, i pasti, per dormire, per l’incontro reciproco.
I registri anagrafici fanno sorgere solo la presunzione che l’immobile sia anche la casa familiare se la famiglia anagrafica è ivi residente.
La casa familiare non deve essere necessariamente di proprietà, potendo anche essere un immobile in affitto.
In tal caso, la legge, infatti, accorda alla casa familiare in affitto una particolare disciplina nel caso di separazione o divorzio: l’immobile, così come quello di proprietà di uno o di entrambi i coniugi, finisce a quello dei due presso cui vanno a vivere i figli.
Non può definirsi casa familiare – e pertanto non può essere oggetto di assegnazione – l’immobile, anche affettivamente importante per la famiglia, che non ha le funzioni sopra precisate, come ad esempio la casa utilizzata saltuariamente o quella utilizzata dai coniugi durante i periodi di vacanza (la casa al mare) o abitata solo per le vacanze, come tutte le “seconde case”.
La casa familiare è unica.
La conseguenza di ciò è abbastanza importante nel caso di separazione. Si pensi a una coppia che viveva in affitto pur avendo una casa di proprietà del marito che però veniva usata solo per le vacanze. In tal caso, il giudice dovrà assegnare alla moglie solo l’immobile in affitto e non anche quello di proprietà del marito usato però saltuariamente.
Pertanto, in caso di separazione, il coniuge che chiede l’assegnazione per sé dell’immobile deve dimostrare che questo era adibito a casa familiare se tale qualità viene contestata dall’altro coniuge.
Nel concetto di casa familiare sono ricompresi anche le parti accessorie come:
– le pertinenze della casa quali ad esempio la cantina e il garage;
– i beni mobili, gli arredi, gli elettrodomestici e i servizi, ad eccezione dei beni strettamente personali o che soddisfino le particolari esigenze del coniuge che viene privato del godimento.
In caso di separazione la casa coniugale si assegna ad uno dei coniugi sulla base di un accordo tra i medesimi intervenuto. Ad esempio possono stabilire che venga venduta, che venga divisa, che venga donata al figlio o accordata alla moglie per un tempo predeterminato in attesa che questa trovi un diverso alloggio. Ciò avviene nella separazione consensuale, quella cioè in cui i coniugi trovano un accordo su tutti gli aspetti del distacco.
In mancanza di accordo, si precede alla cosiddetta separazione giudiziale.
In questi casi le regole sono segnate dalle seguenti variabili:
– se la coppia ha figli minori o maggiorenni non autosufficienti, la casa viene affidata al coniuge presso cui i figli vanno a vivere. Se quest’ultimo è il coniuge non proprietario dell’immobile, quest’ultimo dovrà, suo malgrado, lasciare l’appartamento. Ne potrà venire di nuovo in possesso quando i figli diventeranno grandi o qualora questi ultimi dovessero decidere di andare ad abitare altrove. Il provvedimento di assegnazione relativo alla casa si estende anche ai beni mobili che costituiscono l’arredo della abitazione, a meno che i coniugi non abbiano pattuito (anche al di fuori dei patti omologati in una separazione consensuale) che alcuni beni mobili siano prelevati dalla casa coniugale dal coniuge che ne è proprietario esclusivo. Di regola arredi e altri beni mobili vengono attribuiti, in via provvisoria, all’assegnatario, con facoltà per l’estromesso di prelevare i beni personali (e se c’è accordo tra le parti, anche quelli ai quali tenga particolarmente);
– se la coppia ha figli ormai adulti, con una propria indipendenza economica, la casa resta nella disponibilità del proprietario. In tal caso, se la casa è stata comprata durante il matrimonio tra coniugi in regime di comunione dei beni o se in comproprietà tra coniugi in regime di separazione dei beni, l’immobile va diviso.
Se la divisione è impossibile si dovrà procedere alla vendita con ripartizione del ricavato in moneta.
Quanto alle spese, quando in caso di separazione o divorzio, il giudice assegna la casa coniugale al coniuge non proprietario, nella sentenza dispone che:
a) le spese condominiali ordinarie e tutte le utenze devono essere pagate dal solo coniuge assegnatario, mentre le spese condominiali straordinarie saranno pagate da entrambe le parti in relazione alle quote di singola pertinenza. Qualora il coniuge assegnatario abbia un reddito molto basso, il giudice potrebbe disporre che il pagamento delle spese condominiali sia a carico del coniuge proprietario;
b) in presenza di un mutuo cointestato, le rate continuano ad essere versate da entrambi i coniugi in relazione alle quote di pertinenza. Se invece il mutuo è stato stipulato da uno solo dei coniugi, questi in genere deve continuare a provvedere al pagamento, anche quando non gli sia stata assegnata l’abitazione.
Giurisprudenza
La Cassazione ha affermato che il provvedimento di assegnazione della casa familiare è volto a tutelare esclusivamente l’interesse della prole a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, sicché il provvedimento in questione implica l’accertamento che l’immobile si identifica con il luogo degli affetti, degli interessi, e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l’esistenza della comunità familiare.
L’assegnazione della casa coniugale al coniuge presso cui il minore è collocato trova la sua ragione nell’esigenza di tutelare l’ambiente in cui il figlio è vissuto in costanza di matrimonio e di evitare a quest’ultimo traumi ulteriori rispetto alla separazione dei genitori.
Secondo la giurisprudenza, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale comporta il diritto del beneficiario di continuare a vivere lì in modo gratuito, non anche l’esonero dalle spese legate all’utilizzo della stessa.
Le spese della casa familiare gravano sull’assegnatario.
L’assegnazione della casa coniugale esonera l’assegnatario dal pagamento del canone, al quale si sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo o, del comproprietario dell’immobile assegnato.
La gratuità dell’assegnazione dell’abitazione a uno dei coniugi è relativa all’utilizzo dell’abitazione stessa, per la quale non si deve versare corrispettivo.
Non si estende alle spese correlate a detto uso le quali sono, di regola, a carico del coniuge assegnatario.