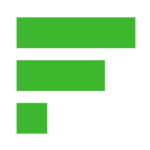Riferimenti normativi
Articoli 1321 e ss. del Codice Civile
Il contratto è definito dalla legge come l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Il contratto è un negozio necessariamente bi o plurilaterale, poiché con esso si compongono interessi che all’inizio erano opposti o quanto meno non coincidenti.
Non esiste contratto con una sola parte; il negozio giuridico contratto deve essere almeno bilaterale, potendo anche coinvolgere un numero maggiore di parti, e cioè plurilaterale.
Con esso si possono costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici.
Più precisamente, costituire significa incidere sulla situazione e sugli interessi delle parti introducendo un nuovo rapporto.
Regolare implica la possibilità di introdurre una qualsivoglia modificazione ad un rapporto già esistente.
Estinguere, invece, significa porre termine ad un rapporto preesistente.
Il contratto, infine, assume sempre una valenza patrimoniale.
Proprio la patrimonialità consente di distinguere il contratto da altri schemi negoziali, come quelli relativi al diritto di famiglia, che, per il loro carattere personale, assumono la qualifica più pregante di convenzioni.
I contratti hanno, quindi, esclusivamente ad oggetto rapporti giuridici patrimoniali. Non sono contratti quei negozi dove manca o non è essenziale l’elemento della patrimonialità, come il matrimonio.
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.
Si parla in questi casi di autonomia contrattuale che possiamo esemplificare in:
-
- libertà di contrarre, intesa come libertà di stipulare o meno un contratto;
- libertà contrattuale, conseguenza della prima, indica il potere delle parti di determinare il contenuto del contratto.
I requisiti del contratto, ovvero i suoi elementi essenziali, sono:
1. l’accordo delle parti
2. la causa
3. l’oggetto
4. la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità
L’accordo (v. Accordo) è l’incontro delle volontà delle parti.
La causa è lo scopo obiettivo del contratto.
Essa incide sulla validità del contratto: infatti, se manca la causa, il contratto è nullo.
I motivi, ovvero gli scopi individuali che inducono due o più parti a estinguere un contratto, non incidono sul medesimo, salvo che siano illeciti, ovvero quando quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito e comune ad entrambe.
L’oggetto è rappresentato dalla cosa o dal diritto che il contratto trasferisce, oppure dalla prestazione che una parte si obbliga a eseguire a favore dell’altra.
L’oggetto deve essere possibile (cioè deve già esistere o puà venire a esistere), lecito (non è contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume) e determinato (deve essere indicata la qualità e la quantità dell’oggetto stesso).
La forma è obbligatoria quando è richiesta ‘ad substantiam’: ad esempio è obbligatoria per il contratto di beni immobili o di beni mobili registrati.
Negli altri casi la forma scritta può anche non esistere poiché vi è il principio della libertà della forma.
La forma “ad substantiam”, quando è richiesta, serve per dare maggiore importanza al contratto.
La forma “ad probationem” è quella richiesta ai fini della prova ma il contratto con questo tipo di forma è valido, anche se non presenta la forma scritta.
I contratti di assicurazione e di transizione sono alcuni esempi di contratti “a probationem”.
Gli elementi accidentali sono quelli elementi che le parti inseriscono nel contatto solo se vogliono, poiché vige l’autonomia contrattuale.
Gli elementi essenziali incidono sull’efficacia del contratto e sono la condizione e il termine.
La condizione (v. Condizione) è un evento futuro incerto dal quale dipende il prodursi degli effetti del contratto. La condizione può essere sospensiva (condizione che quando si verifica fa maturare degli effetti) o risolutiva (gli effetti maturano, ma cessano quando si verifica una condizione).
La condizione deve essere futura (che si deve ancora verificare), incerta (non deve essere previsto il verificarsi), lecita (non contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume). Le norme imperative sono norme che non possono essere derogate dai privati, l’ordine pubblico sono le norme fondamentali dell’ordinamento giuridico e il buon costume sono le norme morali non giuridiche.
Il termine (v. Termine) è un evento futuro certo. Il contratto viene stipulato con termine iniziale quando si esplicita che da un certo momento il contratto inizia a produrre i suoi effetti o con termine finale quando si indica che dopo un certo momento il contratto non può più produrre i suoi effetti. Il termine può essere determinato, quando si indica una data ben precisa, e indeterminato quando si indica un’avvenimento certo (per esempio la morte di una persona).