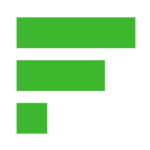Per famiglia mono genitoriale si intende il nucleo dove sia presente un solo genitore con almeno un figlio minore convivente o maggiorenne non economicamente autonomo.
Per i genitori single, è stato coniato nel 2015 il neologismo “Gengle” (GENitori sinGLE).
Più complessa è la definizione di famiglia mono parentale.
In esse rientrano soprattutto le realtà costituite da un genitore separato, divorziato, vedovo o, semplicemente, non convivente con il partner.
Il Parlamento Europeo ha adottato una definizione di famiglia monoparentale intesa come la “realtà differenziate quali genitori che vivono soli con uno o più figli, coppie non legalmente coniugate con figli, genitori soli conviventi oltre che con figli con altri parenti, nuclei di persone conviventi senza vincolo di coppia o di filiazione” .
In Italia i termini di famiglia “mono genitoriale” e “mono parentale” si usano indistintamente per indicare quel nucleo composto dal genitore e figli minori o maggiorenni a carico.
Ne restano così escluse, però, tutte le altre realtà che la famiglia monoparentale – di fatto – abbraccia:
- nonna sola con il nipote minorenne;
- un adulto affidatario di un minore;
- una sorella maggiorenne che si fa carico della sorellina minorenne, ecc.
L’aspetto più importante di queste realtà è la centralità che ha assunto il figlio nel nostro ordinamento.
La legge n. 219 del 2012 (riforma della filiazione) è incentrata sulla tutela dei minori:
- parificazione dei figli naturali e legittimi;
- residenza prevalente del minore per i provvedimenti che lo riguardano;
- riconoscimento del ruolo dei nonni nella vita del bambino;
- la responsabilità genitoriale che sostituisce la potestà genitoriale.
È evidente come nelle realtà mono genitoriali e monoparentali sia assolutamente preminente l’esigenza di occuparsi del mantenimento di uno o più figli e della relativa tutela successoria, garantendo loro anche un futuro sereno dal punto di vista economico per il tempo in cui esso stesso non ci sarà più. Un genitore solo deve, infatti, far fronte ad innumerevoli difficoltà già nella vita quotidiana , con l’ulteriore preoccupazione per il domani.
Con riferimento alla tutela patrimoniale e successoria dei figli di genitori single o soli esistono numerose prospettive, la cui attuabilità è anche influenzata dall’evento che ha originato la famiglia monoparentale.
Occorre, in proposito, analizzare, senza alcuna pretesa di esaustività, le ipotesi più frequenti: famiglie mono genitoriali divenute tali a seguito di separazione, divorzio o cessazione della convivenza; famiglie mono genitoriali divenute tali a seguito di un lutto; genitori single i cui figli siano nati da relazioni instabili.
Ciascuna fattispecie presenta caratteristiche uniche, richiedendo strategie nel campo della tutela successoria e patrimoniale a favore della prole diverse tra loro.
Per i genitori delle famiglie mono parentali appare quanto mai opportuno determinarsi nella scelta di fare testamento, ovvero di effettuare donazioni in vita, di beni o somme ovvero, ancora, di stipulare assicurazioni sulla vita dei genitori a beneficio dei figli.
La particolare, per quanto oramai diffusa, condizione che caratterizza i mono genitori (o mono parenti) impone di interrogarsi circa il futuro dei figli o di altri parenti non autosufficienti per il tempo in cui in mono genitore, unico perno della famiglia, non ci sarà più.
- La situazione, forse, meno traumatica – almeno da un punto di vista patrimoniale – è quella dei figli di coppie separate o divorziate. Gli eventi della separazione e del divorzio, infatti, non hanno alcuna incidenza sulle prospettive successorie dei figli che rimangono ferme, salvo quantificarsi la quota ereditaria a seconda del numero dei figli e di un eventuale nuovo matrimonio dei genitori.
Questa tipologia di famiglia mono parentale, dunque, non pone grosse criticità, né per l’ex coniuge né per i figli, rispetto a quanto già esaminato nel corso della trattazione.
I figli godono pur sempre di una posizione privilegiata nel panorama successorio dei genitori, sia in caso di successione legittima che in caso di successione testamentaria, essendo tutelati anche dalle norme sulla successione necessaria.
- La seconda fattispecie – famiglia mono genitoriale divenuta tale a seguito di un lutto – rappresenta l’ipotesi più delicata, sia da un punto di vista psicologico che patrimoniale.
Dal punto di vista psicologico, perché non nasce da una scelta propria ma da una disgrazia subita. Il vedovo o la vedova avrebbero certamente voluto continuare ad avere accanto il proprio compagno. Da un punto di vista patrimoniale lo scenario che può delinearsi impone, invece, di contemperare l’eredità molto probabilmente ottenuta dal defunto con le prospettive successorie future. Il vedovo è, infatti, destinatario della preventiva acquisizione dell’eredità dell’altro coniuge o del compagno.
Il genitore superstite potrebbe decidere di “congelare” l’eredità del coniuge perduto in favore dei figli, al fine di assicurare loro un futuro in ogni caso il più possibile sereno, almeno dal punto di vista economico, laddove anche egli stesso dovesse venire a mancare.
La strategia cui ricorrere al fine di realizzare quest’obiettivo potrebbe essere quella di rinunciare all’eredità laddove questa andasse così a favore dei figli ovvero disporre per testamento in favore del figlio dell’eredità del defunto. È pacifico che l’eredità possa formare, infatti, oggetto di testamento.
Ciò si verifica nell’ipotesi in cui il testatore disponga mediante legato – ovvero con attribuzione a titolo particolare – di un’eredità alla quale era chiamato egli stesso.
Si pensi, ad esempio, alla madre la quale, essendo chiamata alla successione del defunto marito, decida di devolvere l’eredità a lei destinata direttamente in favore della figlia.
Questo risultato potrebbe realizzarsi anche mediante una rinuncia all’eredità della madre. Ma non è sempre detto che, in caso di rinuncia della madre, la figlia sia chiamata ulteriore alla successione del padre.
Il testatore può aver già – espressamente o tacitamente – accettato l’eredità della quale egli vuole ora disporre, oppure può accadere che egli sia ancora mero chiamato rispetto a tale eredità.
Nella prima ipotesi, a seguito dell’accettazione si è evidentemente realizzata la confusione dell’asse ereditario accettato con il patrimonio del testatore: in tal caso il riferimento all’eredità quale oggetto di legato costituisce semplicemente una modalità più agevole per indicare un complesso i rapporti giuridici che fanno ormai parte del suo stesso patrimonio.
Nella seconda ipotesi, ossia quando il testatore sia ancora chiamato rispetto all’eredità della quale vuole disporre, si sottolinea come l’atto di disposizione dell’eredità non ancora accettata configuri un’ipotesi di accettazione tacita della medesima.
L’aspetto più rilevante da tenere presente relativamente al legato di eredità è quello che concerne la sorte dei debiti relativi all’eredità di cui sia disposto. In proposito occorre distinguere i rapporti esterni, ossia rapporti con i creditori dell’eredità oggetto di legato, dai rapporti interni, ossia i rapporti tra erede (nell’esempio fatto prima, la madre) e legatario (nell’esempio fatto prima, la figlia).
Quanto ai rapporti con i creditori, verso costoro è responsabile l’erede testatore (la madre), in base al principio fondamentale per il quale i debiti ereditari vanno pagati dagli eredi e non dai legatari.
Nei rapporti tra erede e legatario, quest’ultimo (la figlia) deve rimborsare l’erede del testatore (la madre) di quanto questi abbia pagato per debiti e pesi dell’eredità. Tuttavia la responsabilità del legatario è sempre nei limiti del valore dei beni oggetto di legato.
- La terza fattispecie di famiglia mono genitoriale è rappresentata da ragazze madri o ragazzi padre, ovvero da quelle famiglie formatesi a seguito della procreazione di un figlio nell’ambito di una relazione non stabile e non voluto da entrambe le parti ma solo da una.
Pertanto mentre per le famiglie mono genitoriali o mono parentali divenute in un secondo momento tali potrebbe esserci stata una qualche previsione della mono genitorialità con conseguente predisposizione di soluzioni dal punto di vista patrimoniale, nel caso di famiglie mono genitoriali nate proprio così, si è assolutamente soli e da soli si affronta e si prevede il futuro.
Negli ultimi anni stanno trovando massiccia diffusione, in generale ma con particolare riferimento alle famiglie mono genitoriali, le assicurazioni sulla vita.
La presenza di un genitore unico può esporre a disagi maggiori i figli di famiglie monoparentali in caso di imprevisti: non solo i figli minori, ma anche i giovani maggiorenni che, seppur fuori casa e con una loro indipendenza economica, potrebbero ritrovarsi a gestire situazioni complicate e senza un concreto sostegno economico.
Lasciti testamentari, eredità e donazioni sono soluzioni che implicano capitali non immediatamente realizzabili. Essi, infatti, possono solitamente essere riscossi solo dopo tutte le valutazioni legali del caso e per questo potrebbero non essere immediatamente disponibili. I lasciti patrimoniali di questo tipo sono inoltre soggetti a reversibilità, pignoramenti e sequestri, e pertanto non sempre totalmente sicuri per i propri figli.
Stipulare un’assicurazione sulla vita è un modo per garantire un capitale sicuro a una persona cara in caso di imprevisti, per una maggiore serenità di entrambe le parti interessate.
A differenza di altre forme di tutela, infatti, un’assicurazione non è soggetta ad imposte di successione. E ciò rappresenta un notevole vantaggio, non solo dal punto di vista economico – non dovendo sostenere un esborso economico – ma anche dal punto di vista pratico, non essendo richiesto alcun onere per la riscossione del premio.
L’assicurazione sulla vita non è pignorabile, né sequestrabile.
Essa, inoltre, può assolvere a funzioni fondamentali quali la tutela della famiglia nei confronti di debiti importanti (come il mutuo per l’acquisto della prima casa).
Un’assicurazione sulla vita, inoltre, risponde ad un’esigenza di salvaguardia dei propri cari in caso di eventi imprevisti o difficoltà.