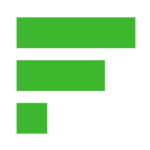Riferimenti normativi
Articoli 230 bis e ter del Codice Civile
Disciplina
L’impresa familiare è un’impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore.
Come nelle società, dunque, è comune a più soggetti lo svolgimento di un’attività economica.
L’impresa familiare è un istituto residuale, tant’è che la legge prevede il ricorso ad essa “salvo che sia configurabile un diverso rapporto”.
Si tratta di una formula che opera solamente se l’attività svolta non può configurarsi con un altro tipo di rapporto, come una società o un’associazione.
È, dunque, una forma marginale di organizzazione imprenditoriale.
È tuttavia ammessa la costituzione di un rapporto di lavoro tra l’imprenditore e il familiare partecipante all’impresa. In tal caso la fonte di regolamento del loro rapporto, da quel momento, sarà il contratto di lavoro.
L’impresa familiare trova il proprio fondamento nell’esigenza di tutelare la par condicio dei familiari e prevenire situazioni di sfruttamento.
Quanto ai soggetti dell’impresa familiare, ne fanno parte il coniuge, i parenti fino al terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore.
Sono ovviamente compresi anche i figli adottivi e quelli naturali.
Perché perduri l’appartenenza all’impresa familiare, inoltre, è necessario che il rapporto familiare persista per tutta la durata dell’impresa stessa.
Le cause di invalidità del matrimonio e il divorzio (ma non la separazione) comportano il venir meno dell’impresa familiare.
La disciplina si applica anche alle parti dell’unione civile, nonché ai conviventi di fatto che prestano lavoro nell’impresa dell’altro convivente.
L’impresa familiare ha carattere di impresa individuale.
Questa, infatti, di fronte alla legge è attribuibile solo al familiare che la esercita, unico ad assumersi la responsabilità per le obbligazioni verso i terzi e ad essere soggetto al fallimento in caso d‘insolvenza.
L’impresa familiare, pertanto, è un’impresa individuale che tutela la posizione delle persone familiari che forniscono il proprio apporto di lavoro, alle quali la legge attribuisce diritti specifici.
Ciò che la caratterizza è il tipo di rapporto che lega i collaboratori.
Per la costituzione dell’impresa familiare non viene richiesto un numero minimo di partecipanti.
Si costituisce per mere circostanze di fatto e sull’origine di rapporti economicamente rilevanti fra imprenditore e familiare.
Non necessita, dunque, dell’atto pubblico o della scrittura privata redatta da un notaio per esistere.
È tuttavia opportuna la redazione di un “atto costitutivo”. Questo al fine di avere un documento sottoscritto dal titolare e dai collaboratori dove siano riportate le quote di partecipazioni agli utili al fine di poter beneficiare della disciplina fiscale e di poter far sorgere un vero e proprio diritto in capo ai collaboratori, da questi esigibile.
Il titolare è l’unico ammesso ad ammettere un familiare – anche minore – all’impresa.
Per poter costituire impresa familiare non è richiesto l’obbligo di convivenza in un’unica famiglia di tutti coloro i quali operano nell’impresa stessa, e che è consentita anche la partecipazione dei figli naturali, riconosciuti dal titolare.
Presupposto per l’applicazione della disciplina è che il familiare presti, all’interno di un’impresa che fa capo al coniuge, a un parente o a un affine, la propria attività lavorativa.
Le attività idonee a rientrare nel campo di applicazione dell’impresa familiare sono le stesse che potrebbero essere oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
Esse, inoltre, devono essere svolte in maniera non saltuaria o occasionale ma continuativa.
Nelle attività lavorative possono essere ricomprese anche quelle oggetto di lavoro domestico.
Tuttavia il lavoro domestico deve, in questo caso, contribuire al miglior andamento dell’impresa familiare. Non rientra, infatti, nelle prestazioni lavorative il normale lavoro domestico svolto in attuazione degli obblighi generali gravanti sui coniugi. Ciò al fine di evitare che della disciplina vengano fatti abusi.
La legge ha inteso tutelare la posizione dei familiari del titolare.
Chi presta la propria attività di collaborazione in modo continuativo può, infatti, esercitare una serie di diritti, proporzionati alla qualità e alla quantità del lavoro prestato nell’impresa familiare.
Si tratta di diritti di natura patrimoniale e di partecipazione alle decisioni dell’imprenditore, quali:
- mantenimento, sulla base della condizione patrimoniale della famiglia;
- partecipazione agli utili dell’impresa e ai beni acquistati con essi;
- partecipazione agli incrementi dell’azienda;
- prelazione, nell’ipotesi di divisione ereditaria o di alienazione dell’impresa.
Il diritto di prelazione in caso di alienazione dell’azienda è esercitabile solo nel caso di cessione a titolo oneroso. L’imprenditore può anche decidere di donare o assegnare con testamento l’impresa a un soggetto da lui prescelto.
La gestione dell’impresa familiare ruota intorno alla figura del titolare, cui spetta l’amministrazione ordinaria in modo autonomo e la rappresentanza dell’impresa.
Per poter gestire la propria impresa, pertanto, il titolare non ha alcun obbligo di condivisione e comunicazione ai suoi familiari ai quali deve tuttavia riferirsi in caso di alcune decisioni particolarmente importanti.
Spettano alla maggioranza dei componenti dell’impresa le decisioni su:
- come utilizzare gli utili e gli incrementi;
- gestione straordinaria;
- indirizzi produttivi;
- cessazione.
Il calcolo della maggioranza viene effettuato per teste e le decisioni vengono assunte senza alcun obbligo di seguire un determinato procedimento.
Non si crea, infatti, un organo decisionale preposto a discutere sugli argomenti sopra elencati e spetta all’imprenditore dare seguito alla decisione assunta.
L’imprenditore che, riguardo tali materie, agisce senza avere il preventivo consenso degli altri familiari o attua una decisione parzialmente scontante da quella da loro adottata rimetterà la propria responsabilità nei rapporti interni con i familiari, dovendo loro risarcire eventuali danni. Restano inalterati i rapporti con i terzi nei confronti dei quali rimane efficace e valida la decisione mossa dall’imprenditore.
Spettano invece all’unanimità dei partecipanti le decisioni sul trasferimento del diritto di partecipazione alla stessa.
Quanto al trasferimento del diritto di partecipazione, tutti i diritti dei partecipanti all’impresa familiare, sia di carattere economico che di carattere amministrativo, vengono complessivamente designati come diritto di partecipazione.
Il diritto di partecipazione all’impresa può essere trasferito solo ai familiari e con il consenso di tutti gli altri partecipanti.
Esso può anche essere liquidato in danaro in caso di cessazione della prestazione lavorativa o in caso di alienazione dell’azienda.
Con riferimento alla cessazione del rapporto con i familiari, l’imprenditore può in ogni momento decidere di estromettere un familiare dall’impresa.
In tale occasione il familiare estromesso può pretendere la quota di utili di sua competenza e gli incrementi maturati.
Si possono individuare alcune ipotesi di cessazione dell’appartenenza del familiare all’impresa ovvero di “rottura” della relazione che lega il familiare alla collaborazione in seno all’impresa, e che possono essere riassunte nelle seguenti casistiche:
- recesso da parte del familiare, con congruo preavviso, al fine di non arrecare pregiudizi alla prosecuzione dell’impresa;
- recesso per giusta causa da parte del familiare, con effetti immediati;
- esclusione del familiare, nel caso in cui si rilevi che lo stesso sia elemento di negatività per la conduzione delle attività di impresa;
- perdita dello status di familiare: è, ad esempio, possibile che il familiare cessi di esser tale perché il matrimonio viene dichiarato nullo, o in seguito a divorzio e separazione. In questo caso, spetterà sempre al titolare dell’impresa la valutazione autonoma della situazione creatasi, al fine di comprendere se essa risulti o meno compatibile con le finalità dell’impresa.
Quanto alla cessazione dell’impresa familiare, si possono evidenziare le seguenti ipotesi:
- decisione del titolare di cessare le attività;
- morte del titolare, con possibilità che la stessa impresa possa proseguire con altri titolari appartenenti alla stessa famiglia; in tal caso, i beni dell’impresa vengono devoluti a favore del suo asse ereditario. Ai familiari partecipanti all’impresa spetta solo una quota di beni o di utili o di incrementi e il diritto di prelazione.
- alienazione dell’azienda, ferme restando le regole legate al diritto di prelazione;
- fallimento del titolare.
Sotto il profilo fiscale il reddito dell’impresa familiare viene attribuito al titolare e ai collaboratori per trasparenza in base alle quote di partecipazioni agli utili.
“I redditi delle imprese familiari di cui all’articolo 230 bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”.
Ai collaboratori dell’impresa, pertanto, viene attribuita la parte di reddito prodotta in relazione alle quote di partecipazione agli utili stabilite nell’atto costitutivo non oltre il 49%. Al titolare invece sarà attribuito un reddito nella percentuale minima del 51 %.
Affinché il reddito possa essere attribuito al collaboratore familiare è rilevante quanto dispone la lettera a) del quarto comma dell’articolo 5: “a) che i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativamente, con l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell’imprenditore e dei familiari partecipanti;”. 0.
Anche ai fini delle imposte sui redditi si intendono per familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Giurisprudenza
L’istituto ha carattere residuale rispetto ad ogni altro tipo di rapporto negoziale ed è incompatibile con la disciplina delle società di qualunque tipo. Titolo dei diritti del collaboratore è il lavoro prestato sulla base del rapporto familiare; ogni diverso titolo, di scambio od associativo (id est contratto di lavoro, di società o di associazione) esclude, come afferma il proemio della norma, la fattispecie in esame.
La giurisprudenza ha sostenuto la natura individuale dell’impresa familiare, innanzitutto perché strutturalmente l’istituto non fa parte dell’ambito del codice civile dedicato al lavoro e alle società, bensì trova spazio in quello dedicato alle persone e alla famiglia. In secondo luogo, configurare l’impresa familiare come impresa individuale ha come conseguenza che solo l’imprenditore sarà il titolare dell’impresa, con esclusione di ogni forma di partecipazione dei familiari alla gestione ordinaria della stessa.
L’impresa familiare di cui all’articolo 230- bis è, dunque, un’impresa individuale e il familiare titolare della stessa, quindi, è l’unico soggetto passivo obbligato in relazione ai diritti di credito spettanti a ciascuno dei familiari che collaborano all’impresa stessa ed esclusivo legittimato a resistere alle pretese fatte valere da costoro.
La giurisprudenza ha, inoltre, affermato che non costituisce causa automatica di cessazione dell’impresa familiare la separazione dei coniugi partecipanti alla stessa. L’intervenuta separazione personale tra i coniugi non comporta “ipso iure” ed in assenza di qualunque altro accertamento di fatto sulle diverse modalità di concreto svolgimento dell’attività professionale, l’automatica e necessaria cessazione dell’impresa familiare ex articolo 230-bis del codice civile già esistente tra i coniugi stessi.