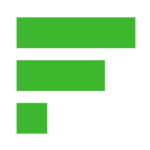Riferimenti normativi
Articoli 120, 428, 591, n. 3, 775, 2046, 2047, co. 2 del Codice Civile.
Disciplina
L’incapacità naturale concerne la situazione di un soggetto che, pur non essendo legalmente incapace di agire, sia comunque «per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere al momento in cui gli atti sono compiuti».
La legge si riferisce genericamente agli «atti compiuti da persona incapace di intendere e di volere».
L’incapacità naturale si contrappone al concetto di incapacità legale e si riferisce alla situazione in cui un soggetto, pur non essendo assoggettato ad una limitazione giudiziale della capacità di agire, al momento del compimento dell’atto, sia concretamente incapace di intendere e di volere, per qualsiasi causa, anche transitoria.
La ratio è quella di bilanciare la tutela dell’incapace e l’affidamento della controparte, nonché la sicurezza e la velocità del traffico giuridico.
Ciò in quanto l’incapacità naturale non risulta ufficialmente dai registri dello stato civile: ragion per cui, si ravvisa la necessità di tutelare i terzi che con tale soggetto vengano in contatto.
Oltre che nell’art. 428 c.c., l’incapacità naturale si ritrova in norme specifiche, concernenti il matrimonio (art. 120 c.c.), il testamento (art. 591, n. 3 c.c.) e la donazione (art. 775 c.c.): in tali casi, l’annullabilità è comminata in presenza della sola incapacità, non essendo necessario nessun altro requisito, poiché qui la lesione della sfera dell’incapace è ritenuta in re ipsa. Inoltre, l’art. 2046 c.c. considera imputabile (e conseguentemente responsabile) solo il soggetto dotato di capacità naturale (essendo altrimenti possibile solo disporre a suo carico un’indennità, tenuto conto delle condizioni economiche di entrambe le parti, ex art. 2047, co. 2, c.c.).
Si afferma, di solito, che, mentre l’incapacità legale sia una situazione di diritto, quella naturale integri una situazione di fatto.
Infatti, l’incapacità legale è accertata in base a criteri sostanziali e/o procedimentali e risulta ufficialmente dai registri dello stato civile, garantendo così la certezza delle contrattazioni.
Se il soggetto è interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno (limitatamente agli atti inclusi nel decreto di nomina), la sua incapacità si presume iuris et de iure, determinando l’annullabilità degli atti posti in essere da questi senza la sostituzione o l’affiancamento rispettivamente del tutore, del curatore o dell’amministratore di sostegno.
Nei casi di incapacità legale, pertanto, non occorre dimostrare, di volta in volta, la situazione psicologica del soggetto al momento dell’atto, ma anzi l’incapacità naturale è presupposta dagli istituti di incapacità legale, che consentono così una tutela nei confronti di tutti gli atti della vita quotidiana.
Si è detto che l’incapacità naturale si riferisce ad un soggetto privo della capacità di intendere e di volere per il compimento di uno specifico atto.
Mentre l’interdizione richiede un’incapacità totale ed assoluta, nell’incapacità naturale è sufficiente che le facoltà psichiche del soggetto siano ridotte.
Solo in relazione all’art. 591, n. 3, c.c., la giurisprudenza richiede che le attitudini del soggetto siano totalmente menomate (ma qui si vuole preservare il più possibile la validità del testamento, quale atto non ripetibile).
L’opinione maggioritaria è, inoltre, nel senso che non occorra ravvisare sia l’incapacità di intendere che quella di volere, data la formula disgiuntiva adoperata dalla legge. Mentre per l’interdizione occorre che l’incapacità di provvedere ai propri interessi sia caratterizzata da abitualità, per l’incapacità naturale non rilevano né la causa generatrice dell’incapacità né la sua ampiezza temporale.
Oggi le sue cause ricomprendono qualsiasi menomazione della sfera intellettiva e volitiva, anche non patologica: ad esempio, i casi di ubriachezza o di tossicodipendenza; la suggestione ipnotica; l’età avanzata; le infermità fisiche; gli stati passionali acuti; l’intenso bisogno di denaro e, persino, la suggestione, la sorpresa, l’inesperienza e l’immaturità. Di per sé, non vengono invece ritenuti rilevanti i disturbi caratteriali o la depressione cronica.
Giurisprudenza
In tema di annullamento del testamento, l’incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius”, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poichè lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo.