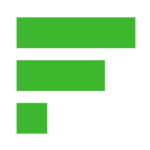(v. Interessi)
Riferimenti normativi
Articoli 820, 1282, 1284,
Disciplina
Gli interessi legali sono quelli che trovano la propria fonte nella legge e rappresentano, di fatto, il costo del denaro.
Il denaro, infatti, è un bene fruttifero e gli interessi sono i frutti civili prodotti dallo stesso. Si contrappongono ai frutti naturali che provengono direttamente del bene (si pensi ai prodotti agricoli) e la legge li definisce come i frutti che si traggono come corrispettivo dal godimento del denaro.
Sono legali gli interessi che trovano la propria fonte nella legge, ossia:
– sono riconosciuti per legge (art. 1282 c. 1 c.c.),
– sono determinati per legge (art. 1284 c.c.), infatti, il tasso di interessi (il cosiddetto “saggio”) viene definito, ogni anno, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi, tenuto conto del tasso di inflazione che è stato registrato nel corso dell’anno.
Sull’importo mutuato (il capitale), il mutuatario paga gli interessi, che sono il corrispettivo spettante per aver concesso la somma in prestito (interessi corrispettivi), i suddetti interessi possono essere al tasso legale (stabilito per legge) o convenzionale (deciso tra le parti); sugli interessi scaduti – se previsto nel contratto – si pagano altri interessi, i cosiddetti interessi sugli interessi, se il mutuatario tarda nel pagamento delle rate, deve corrispondere gli interessi moratori, ossia sul ritardo.
Gli interessi corrispettivi cessano di essere dovuti con la mora, sostituiti da quelli moratori, salvo diversa convenzione tra le parti.
Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5% in ragione d’anno.
Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La funzione degli interessi legali è remuneratoria. Trovano fondamento nel principio della naturale fecondità del denaro, ossia il principio secondo cui la disponibilità nel tempo del denaro altrui va pagata perché integra un obiettivo vantaggio economico. Gli interessi altro non sono se non il costo del denaro ovvero, , il denaro genera denaro.
Gli interessi legali sono stabiliti dalla legge e anche determinati dalla stessa; pertanto, nel caso in cui le parti non convengano, tra loro, l’entità degli interessi, si applica automaticamente il tasso legale. Lo stesso accade per gli interessi moratori, che operano al tasso legale, se i contraenti non hanno deciso diversamente.
Quanto al calcolo degli interessi legali, essi maturano nel tempo (periodicità) sono calcolati con un saggio (percentualità) in relazione al capitale a cui accedono (accessorietà). Il calcolo degli interessi, quindi, deve far riferimento ai seguenti elementi:
- capitale,
- saggio o tasso percentuale,
- tempo.
Gli interessi maturano temporalmente, in quanto sono dovuti in ragione del tempo in cui il debitore gode del capitale.
La misura degli interessi legali è comunemente detta “saggio”. È variabile, in quanto il tasso è determinato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ogni anno, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi, tenuto conto del tasso di inflazione che è stato registrato nel corso dell’anno (art. 1284 c. 1 c.c.). La ratio della norma è la seguente: la determinazione della misura degli interessi è rimessa al legislatore al fine di avere dei criteri di certezza.
L’art. 1282 c.c. nei commi 4 e 5 rinvia al saggio di interessi previsto per le transazioni commerciali (d. lgs. 231/2002). Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il primo semestre del 2020, ha lasciato inalterato il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi di mora da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, che risulta pari allo 0%. A tale tasso, va aggiunta la maggiorazione dell’8% (anteriormente al 01.01.2013 era pari al 7%).
Il saggio degli interessi moratori – applicabile ex art. 1282 c. 3 e 4 anche in caso di domanda giudiziale e arbitrato – resta confermato all’8% anche per il primo semestre 2020.
Il tasso d’interesse viene stabilito con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ogni anno. In particolare, il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5% in ragione d’anno. Il Ministero, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
Alle parti è data facoltà di stabilire un diverso saggio di interesse, maggiore o minore, rispetto a quello legale, purché non usurario e risultante per iscritto (art. 1284 c. 3 c.c.).
Gli interessi scaduti possono produrre altri interessi, i cosiddetti interessi sugli interessi o interessi composti o secondari; fenomeno anche noto come anatocismo (art. 1283 c.c.). Si parla anche di capitalizzazione, infatti, gli interessi primari vengono sommati al capitale sul quale sono stati calcolati per produrre ulteriori interessi, detti secondari.
Salvo usi contrari (anatocismo usuario), gli interessi scaduti possono produrre altri interessi:
- quando il creditore ne chieda il pagamento con domanda giudiziale (anatocismo giudiziale),
- quando le parti abbiano concluso una pattuizione in tal senso (anatocismo convenzionale).
In ambo i casi si deve trattare di interessi dovuti da almeno 6 mesi (capitalizzazione semestrale).
La domanda giudiziale con cui si chiedono gli interessi anatocistici o secondari è autonoma rispetto alla domanda con cui si chiede il pagamento degli interessi principali.
È vietato l’anatocismo bancario per i contratti stipulati con decorrenza 01.01.2014, infatti, gli interessi capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori (art. 120 c. 2 TUB e D.M. 3 agosto 2016 n. 343).
Il nuovo saggio degli interessi legali stabilito con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (D.M. 12.12.2019), con decorrenza 1° gennaio 2020 è pari allo 0.05% annuo a fronte della misura pari allo 0,80% applicabile per l’anno 2019; allo 0,30 % per l’anno 2018 e allo 0,10 % per l’anno 2017.
Gli interessi legali si producono su depositi cauzionali. Al momento della conclusione del contratto di locazione, sia esso ad uso abitativo o commerciale, solitamente, viene versato anche il deposito cauzionale (art. 11 legge 392/1978); si tratta di una somma posta a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del conduttore, oltre che degli eventuali danni dallo stesso provocati. La cauzione non può superare le 3 mensilità ed è produttiva di interessi, pertanto, al momento della scadenza contrattuale, il locatore dovrà restituirla maggiorata degli interessi maturati. Sul deposito cauzionale, infatti, maturano gli interessi legali annui. Il locatore deve corrispondere al locatore gli interessi sulla cauzione:
al termine di ogni anno, oppure alla scadenza contrattuale.
Il diritto del conduttore agli interessi maturati sul deposito cauzionale si prescrive in 5 anni (art. 2948 n. 4 c.c.).
Naturalmente, la cauzione verrà restituita al conduttore, maggiorata degli interessi maturati, solo allorché riconsegni l’immobile nelle stesse condizioni in cui lo ha ricevuto (si rinvia alla guida sulle locazioni abitative e sulle locazione commerciali).
INTERESSI LEGALI E INTERESSI MORATORI: LE DIFFERENZE
La classificazione degli interessi varia a seconda della loro funzione. Gli interessi di pieno diritto o corrispettivi (art. 1282 c.c.) sono quelli prodotti dal denaro in virtù del principio della naturale fecondità. Il denaro è un bene fruttifero, in altre parole si può dire che il denaro genera altro denaro, sotto forma di interessi.
Gli interessi corrispettivi:
– sono prodotti da crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro a prescindere dalla morosità, ovvero
– sono dovuti per la facoltà di godimento di un capitale (si pensi al mutuo).
Gli interessi moratori traggono origine da un ritardo nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria (art. 1224 c.c.), ossia di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro. Al soggetto che riceve con ritardo la prestazione spettano, dal giorno della mora, gli interessi per il ritardo, anche se non ha subito alcun danno.
Mentre gli interessi corrispettivi sono dovuti a prescindere dalla colpa del debitore; gli interessi moratori non sono dovuti se il debitore dimostra che il ritardo è dipeso da un fatto a lui non imputabile. Gli interessi corrispettivi cessano di essere dovuti con la mora, sostituiti da quelli moratori, salvo diversa convenzione tra le parti.
Quanto alla misura in cui sono calcolati gli interessi moratori, sono dovuti nel tasso legale, se le parti non hanno pattuito interessi convenzionali di misura superiore, in tal caso, gli interessi moratori sono dovuti la tasso stabilito dai contraenti (anche se maggiore di quello legale).
Pertanto gli interessi dovuti per il mero uso di denaro altrui sono corrispettivi (art. 1282 c.c.); gli interessi pagati a causa del ritardo nell’adempimento sono moratori (art. 1224 c.c.); la misura degli interessi moratori può essere quella prevista per gli interessi legali, se le parti non hanno convenuto diversamente.
Una disciplina peculiare è dettata in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (d. lgs. 231/2002). Tale normativa si applica ai contratti conclusi:
- tra imprese (compresi i liberi professionisti),
- tra imprese e pubbliche amministrazioni
- che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo (art. 2 lett.a) d. lgs. 231/2002).
La legge distingue tra:
- interessi legali di mora formati da una componente variabile, comunicata ogni 6 mesi dal Ministero dell’Economia e da una componente fissa, pari a 8 punti percentuali;
- interessi concordati tra imprese, diversi dagli interessi legali di mora.
Da quanto sopra emerge che il saggio legale degli interessi di mora nelle transazioni commerciali è più elevato del tasso d’interesse legale applicabile alle obbligazioni pecuniarie ex art. 1284 c.c., si parla a tal proposito di interessi commerciali.
La legge indica, altresì, precisi termini di decorrenza automatica degli interessi – ossia senza costituzione in mora – nel caso in cui il termine per il pagamento non sia presente nel contratto, si applicano i seguenti termini (art. 4 d. lgs. 231/2002):
- 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- 30 giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
INTERESSI LEGALI E INTERESSI CONVENZIONALI: LE DIFFERENZE
La classificazione tra interessi legali e convenzionali riguarda la fonte:
- la legge nel caso degli interessi legali,
- l’autonomia negoziale nell’ipotesi degli interessi convenzionali.
L’accordo tra le parti riguarda solo la misura degli interessi e non la loro “debenza”, la misura del tasso deve risultare per iscritto, in difetto, gli interessi restano dovuti al saggio legale (art. 1282 c. 2 e 3 c.c.).
Il tasso convenzionale può essere inferiore a quello legale oppure superiore, purché non usurario. Solitamente, la misura dell’interesse convenzionale supera quello legale; il tasso di interesse ultralegale non può superare il cosiddetto tasso soglia stabilito dalla legge relativamente alle varie operazioni, si pensi al contratto di mutuo.
Se la pattuizione supera la misura del predetto tasso soglia, gli interessi si considerano usurari, la clausola è nulla e gli interessi non sono dovuti. Il tasso soglia è quello in vigore al momento della pattuizione a prescindere dal momento del pagamento (d. l. 394/2000, art. 1 c. 1)
La rivalutazione monetaria persegue lo scopo di adeguare la somma alle variazioni del costo della vita.
Pertanto, il calcolo degli interessi deve operare, di anno in anno, sulle somme rivalutate. Infatti, gli interessi che vengono a maturare sulla somma soggetta a rivalutazione devono essere calcolati tenendo conto che la rivalutazione ha natura progressiva.