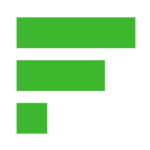Riferimenti normativi
Articoli 533 e ss. del Codice Civile
La petizione di eredità è l’azione che l’erede (v. Erede) può esercitare per vedere riconosciuta la sua qualità di erede contro chiunque possiede in tutto o in parte i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno. Scopo ultimo dell’azione è la restituzione dei beni ereditari.
L’azione, che spetta solo all’erede, è imprescrittibile, ma sono fatti salvi gli effetti dell’usucapione eventualmente intervenuta.
Si tratta di un’azione speciale concessa all’erede, che ha in comune con la rivendica il carattere della imprescrittibilità.
Questa azione tende a far conseguire all’erede il possesso dei beni ereditari, ma si distingue dalle azioni possessorie (v. Azioni possessorie), oltre per la sua imprescrittibilità, per le diverse condizioni necessarie per poterla esperire. Non è previsto, infatti, che vi sia stato spoglio violento o clandestino del possesso, e legittimato attivo può essere solo l’erede (o chi affermi di essere tale) e non il semplice possessore.
Si tratta, quindi, di azione di condanna, ma nulla vieterebbe all’erede di agire solo per chiedere l’accertamento della sua qualità in presenza di contestazioni.
In quest’ultimo caso, però, non rientriamo più nell’ipotesi dell’art. 533, ma nel generale potere di esercitare l’azione di accertamento che è senza dubbio riconosciuto a tutti i titolari di diritti assoluti.
Quanto ai presupposti, occorre il possesso dei beni ereditari da parte di un terzo che si afferma erede o che possegga senza alcun titolo.
Il legittimato attivo all’azione è l’erede, ma anche il coerede può agire con la petizione dell’eredità.
Il legittimato passivo è il possessore erede apparente e il possessore senza titolo.
Lo scopo dell’azione è l’accertamento della qualità di erede e la condanna del possessore alla restituzione dei beni ereditari.
Se il possessore era in buona fede ed ha alienato i beni ereditari, all’erede sarà dovuto il prezzo o il corrispettivo ricevuto, ma se era in male fede dovrà recuperare la cosa, o, in mancanza, corrisponderne il valore, oltre al risarcimento del danno.
L’azione dell’erede si rivolge contro chi dichiari di essere lui l’erede (l’erede apparente), e contro chi possegga, ma senza alcuno titolo, ma non contro chi vanti un titolo qualsiasi di acquisto, ma diverso da quello ereditario; si pensi al caso in cui l’erede voglia agire contro una persona che affermi di aver comprato i beni dal defunto; in questa ipotesi l’erede non dovrà agire con l’azione di petizione dell’eredità, ( che del resto sarebbe inutile, visto che nessuno contesta la sua qualità di erede), ma con la rivendicazione.
Una volta riconosciuta la qualifica di erede all’attore, il convenuto dovrà restituire i beni ereditari.
Nelle restituzioni è rilevante la buona fede del convenuto; la legge prevede, infatti, che al possessore si applicano le regole generali in tema di possesso per le restituzioni, miglioramenti e addizioni, ma non si applica la regola dell’art. 1153 c.c. sulla rilevanza del possesso di buona fede per l’acquisto dei beni mobili.
Anche se l’acquisito dei beni è avvenuto in buona fede, si sarà tenuti alle restituzioni, pure se si tratta di beni mobili, e se, per avventura, il bene, sempre in buona fede, sia stato venduto, all’erede spetterà il corrispettivo ricevuto dal venditore.
Sempre in applicazione delle regole generali, invece, è sufficiente che la buona fede esista nel momento dell’acquisto, mentre, nel caso di vendita dei beni ereditari, deve esistere anche nel successivo momento dell’alienazione.
Di conseguenza se l’alienazione è avvenuta in mala fede bisognerà restituire il valore reale del bene, anche se superiore al prezzo ricevuto per l’alienazione, oltre al risarcimento del danno.
La legge prevede, infine, che per l’erede apparente la buona fede consista nell’errore sulla sulla sua qualità di erede, errore che però non gli giova se deriva da colpa grave.