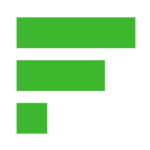Riferimenti normativi
Articoli 1027 e ss. del Codice Civile
La servitù è un diritto reale limitato che consiste nel peso imposto sopra un fondo, denominato servente, per l’utilità di un altro fondo, denominato dominante, appartenente a diverso proprietario.
Essa, nello specifico, si sostanzia in un peso che grava su un terreno o edificio (il fondo) a favore di un altro terreno o edificio.
In sostanza la servitù sta ad indicare asservimento, assoggettamento, subordinazione di una cosa rispetto ad un’altra.
Quanto alle caratteristiche della servitù è necessario, in primo luogo, che i due fondi, servente e dominante, appartengano a due proprietari diversi.
L’obbligo che grava sul terreno o edificio servente (il peso), inoltre, non può mai consistere in un obbligo positivo, ovverosia in un dover fare o dover dare, ma, sempre, in un obbligo negativo, di astensione, di non fare e, spesso ma non sempre, di lasciar fare.
Per il fondo dominante l’obbligo gravante sul fondo servente corrisponde ad un diritto, che può consistere tanto in un poter avere o fare qualcosa, ma anche nel diritto che il proprietario del fondo servente non faccia o si astenga dal fare
L’utilità per il fondo dominante deve essere per sua natura durevole: non è possibile che vi sia servitù tra fondi in presenza di un bisogno transitorio del proprietario del fondo potenzialmente dominante: solo un’esigenza permanente, anche se non perpetua, può legittimare la costituzione di una servitù.
E’ ammissibile la costituzione di una servitù per assicurare a un fondo un vantaggio futuro e quindi non attuale, così come una servitù a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare, ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l’edificio è costruito o il fondo è acquistato, e quindi dal momento in cui i beni gravati vengono ad esistenza o divengono di proprietà di colui che beneficia della costituzione.
I fondi devono essere vicini; non è necessaria la contiguità, ma la vicinanza deve essere tale da consentire che vi possa essere l’utilità derivante dall’asservimento.
La servitù, infine, dovrà essere unilaterale, nel senso che deve essere ben distinguibile qual è il fondo sul quale grava il peso (lo svantaggio o la compressione del diritto di proprietà) a favore dell’altro, non potendo concentrarsi in capo ad uno dei due terreni coinvolti entrambe le qualifiche di “dominante” e di “servente”.
In base a tale principio, parte della dottrina ha negato l’esistenza delle c.d. servitù reciproche, respingendo la tesi che lo stesso fondo possa rivestire, contemporaneamente, in ordine alla stessa utilità oggettiva, la qualità di servente e dominante, posto che la caratteristica fondamentale del diritto di servitù è quella di ius in rea aliena. Tuttavia, per altra parte della dottrina e per la giurisprudenza, non si può escludere che due fondi possano essere gravanti reciprocamente dalla medesima servitù, poiché il rapporto che viene a costituirsi in tal caso non è quello di corrispettività tra i due fondi, bensì quello relativo a due diverse ed autonome servitù in cui il fondo che nell’una è considerato come servente, nell’altra figura come dominante.
Quanto alla costituzione, si distingue tra servitù volontarie e coattive, a seconda che trovino la propria fonte nella volontà delle parti o nella legge.
Quanto alla servitù volontaria, essa si può costituire una servitù a favore di un altro soggetto in modo volontario con atto inter vivos cioè con contratto o con atto mortis causa cioè con testamento. Il contratto può essere a titolo gratuito e dovrà rivestire la forma della donazione. Non è possibile costituire una servitù con atto unilaterale che non sia mortis causa cioè testamento.
Le servitù coattive, invece, sono un numero limitato di servitù corrispondenti a quelle particolari situazioni nelle quali il legislatore ha riscontrato la necessità di imporre un peso su di un fondo a favore di un altro fondo, al fine di consentire al proprietario di questo fondo una proficua utilizzazione. Sono quelle particolari situazioni nelle quali, in mancanza di contratto e quindi di accordo, la servitù viene costituita a seguito di una sentenza o con atto amministrativo da parte della pubblica amministrazione. Anche in osservanza di un contratto, il titolare del fondo dominante deve corrispondere una indennità in favore del titolare del fondo servente. La sentenza o l’atto amministrativo stabilisce le modalità della servitù e determina l’indennità. Il pagamento dell’indennità è indispensabile perché il titolare della servitù possa esercitare il suo diritto altrimenti il titolare del fondo servente può opporsi.
Sono servitù coattive:
– servitù di acquedotto e scarico;
– servitù di somministrazione di acqua;
– servitù elettrodotto coattivo;
– servitù di passaggio coattivo.
Le servitù volontarie possono essere costituite per contratto o per testamento, negozi per i quali è richiesta la forma scritta a pena di nullità ), nonchè la trascrizione nei pubblici registri immobiliari.
Le servitù possono essere costituite anche “per usucapione o per destinazione del padre di famiglia”.
Si ritiene che tali modi di costituzione riguardino esclusivamente le servitù volontarie e non anche quelle coattive, sebbene queste ultime possano costituirsi anche mediante atto negoziale.
Affinchè possa acquistarsi la servitù per usucapione o destinazione del padre di famiglia è necessario il requisito dell’apparenza, che si configura come presenza di segni visibili di “opere permanenti” obiettivamente destinate al suo servizio e rivelanti in modo inequivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, ma di preciso onere a carattere stabile.
In relazione all’acquisto per usucapione, la ratio della visibilità e permanenza delle opere va individuata nella possibilità per il proprietario del fondo, destinato a diventare servente, di reagire all’eventuale usurpazione del suo diritto (che culmina nell’acquisto della servitù in favore del possessore), escludendo la clandestinità del possesso, o la mera tolleranza e facendo presumere che il proprietario del fondo servente abbia contezza dell’obiettivo asservimento della proprietà a vantaggio del fondo dominante.
Quanto all’acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia, questa ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Le servitù si distinguono in:
– servitù volontarie: sono quelle che nascono in virtù di un atto dell’uomo, e quindi per volontà dei proprietari del fondo dominante e del fondo servente (per esempio mediante contratto);
– servitù coattive: sono quelle nascono perché è la legge stessa a prevedere e imporre la loro costituzione.
– servitù apparenti: sono quelle servitù nelle quali l’utilità o il corrispondente peso necessitano di opere visibili e permanenti;
– servitù non apparenti: sono quelle che, per esistere, non hanno necessità di manifestarsi esteriormente con opere visibili e permanenti.
– servitù positive: sono quelle nelle quali il proprietario del fondo servente deve sopportare l’attività del proprietario del fondo dominante;
– servitù negative; sono quelle nelle quali il proprietario del fondo servente è limitato in una o più delle facoltà che sono generalmente attribuite al proprietario e ciò sempre in vantaggio del fondo dominante.
– servitù continue: sono continue quelle per il cui esercizio non è necessaria l’attività umana;
– servitù discontinue: sono quelle per le quali è necessaria l’attività umana.
I casi in cui il diritto di servitù si estingue sono:
– quando il diritto di servitù è stato sancito mediante un contratto tra le parti e tale accordo fissa una data scadenza per il quale, al sopraggiungere di tale termine, decadrà anche il diritto;
– quando il proprietario del fondo dominante rinunci di sua volontà al proprio diritto;
– quando il proprietario del fondo servente rinunci alla proprietà del fondo;
– nel caso in cui, tramite una sentenza, si accerta che la servitù non è più necessaria;
– nel momento in cui la medesima persona diventi proprietaria sia del fondo dominante che di quello servente;
– quando il diritto da parte dal proprietario del fondo dominante non viene più esercitato per almeno venti anni.
Giurisprudenza
La legge sottolinea la peculiare importanza del titolo, ponendo il suo contenuto quale fonte preminente ai fini dell’individuazione tanto dell’estensione quanto delle modalità di esercizio della servitù.
La validità del titolo, del resto, è l’unica condizione da rispettare per la regolare costituzione del diritto, giacchè la trascrizione dell’atto costitutivo, è la forma di pubblicità prescritta non già per il perfezionamento della servitù medesima ma solo per la sua opponibilità ai terzi.
E’ pacifico in giurisprudenza che, nel caso di costituzione negoziale della servitù, il titolo debba contenere tutti gli elementi atti ad individuare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l’utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario, con la specificazione dell’estensione e delle modalità di esercizio.
Pur non essendo necessario l’uso di formule sacramentali, si ritiene in ogni caso non sufficiente una c.d. “clausola di stile”, essendo indispensabile l’estrinsecazione della precisa volontà del proprietario del fondo servente diretta a costituire la servitù e la specifica determinazione nel titolo di tutti gli elementi atti ad individuarla.
La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, secondo la giurisprudenza, postula dunque: – che l’originario unico proprietario di due fondi (o di due porzioni) di un fondo abbia eseguito opere permanenti (o durature), tali da rendere evidente l’oggettiva situazione di asservimento o servizio tra gli stessi, non essendo sufficienti opere amovibili o comunque temporanee a denotare l’esistenza del peso gravante sul fondo servente; che tali opere siano apparenti, in modo da rendere certi e manifesti a chiunque, anche, quindi al titolare del fondo gravato, il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto; il requisito dell’asservimento non va ricercato nella volontà (intenzione negoziale) del proprietario ma nella natura dell’opera obiettivamente considerata, che, nel suo utilizzo normale, determina l’asservimento permanente di un fondo a favore dell’altro.
La volontà diretta alla costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è, dunque, irrilevante. Tuttavia, l’art. 1062, comma 2, c.c. dispone che “se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s’intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati”, facendo posto, dunque, all’aspetto negoziale, in assenza del quale, nonostante lo stato dei luoghi induce a ritenere sussistenti gli estremi per costituire una simile servitù, questo non avviene. La “disposizione relativa alla servitù” che ai sensi dell’art. 1062 potrà impedirne la nascita, nonostante lo stato di fatto preesistente, non è desumibile, però, per la giurisprudenza, da facta concludentia, dovendo risultare da una clausola espressa.
E’ ammissibile l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell’ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso “ad usucapionem”.
Il principio “nemini res sua servit” trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell’altro, giacché in tal caso l’intersoggettività del rapporto è data dal concorso di altri titolari del bene comune.