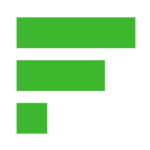Nell’arco della vita ogni individuo raccoglie un patrimonio (v. anche Patrimonio).
Il patrimonio può essere più o meno ingente, composto da beni materiali o anche immateriali e da, in generale, situazioni giuridiche.
La legge assicura che il patrimonio abbia sempre un suo titolare, stante l’esigenza di evitare che i rapporti giuridici facenti capo al defunto si estinguano, diventando “cosa di nessuno”.
Il fondamento della successione a causa di morte è da rinvenire in particolari esigenze economico sociali.
In primo luogo, l’esigenza di tutelare la famiglia, consentendo ad essa di godere di quanto lasciato dal defunto, frutto del sacrificio sostenuto con lui anche dai suoi cari.
In secondo luogo, l’esigenza di tutelare la proprietà, istituto cui il legislatore del nostro ordinamento dà massima importanza.
Infine, l’esigenza di assecondare il passaggio generazionale nell’ambito di realtà dinamiche e produttive.
La successione a causa di morte è un fenomeno che si articola in più fasi, logicamente e temporalmente successive l’una all’altra.
Presupposto è sempre l’esistenza di un cd. “relictum”, ossia un patrimonio (attivo o passivo, essendo possibile anche la “damnosa hereditas”).
1) La prima fase si ha con l’APERTURA DELLA SUCCESSIONE: indica un momento temporale e spaziale.
La successione si apre al momento e nel luogo della morte del soggetto.
2) La seconda fase si individua in quelle che, tecnicamente, si definiscono VOCAZIONE, ossia l’astratta designazione dei successibili e DELAZIONE, ossia l’offerta in concreto dell’eredità ai successibili, che solo con l’accettazione divengono successori.
In questa fase viene in rilievo la fonte della successione.
La trasmissione mortis causa dei beni, può, infatti, avvenire:
- per legge, se è la legge che indica i successibili.
- per testamento, se è il testatore che li individua prima della morte.
La successione testamentaria prevale su quella per legge.
Quest’ultima viene in rilievo solo quando manchi, in tutto o in parte , quella per testamento.
La successione può avvenire:
- a titolo universale (in una quota dei beni), acquistando la qualità di EREDE.
- a titolo particolare (in un singolo bene), acquistando la qualità di LEGATARIO.
LA legge contempla dei meccanismi alternativi di delazione:
- TRASMISSIONE
- RAPPRESENTAZIONE
- SOSTITUZIONE
- ACCRESCIMENTO
**** Testamento
Il testamento è registrato al registro Generale dei Testamenti (v Registro Generale dei Testamenti).
Al momento della notizia della morte o su richiesta di qualunque interessato, il Notaio procede all’apertura/pubblicazione di testamento.
Con il testamento si ha la vocazione e la delazione (v. Vocazione e Delazione) dei successori.
Se i soggetti nominati nel testamento accettano quanto loro devoluto, si ha acquisto dell’eredità e concreto trasferimento del patrimonio pro quota agli eredi.
Si dovrà successivamente procedere ad un successivo atto di divisione, salvo che il testatore non abbia provveduto egli stesso ad assegnare direttamente i beni, evitando la divisione.
****
3) La terza fase è rappresentata da L’ACQUISTO O LA RINUNCIA (v. Rinuncia all’eredità) all’eredità o al legato.
L’acquisto dell’eredità avviene con l’accettazione (v. Accettazione dell’eredità in generale).
L’accettazione può essere avvenire:
- espressamente
- tacitamente
L’accettazione espressa può a sua volta essere:
- Pura e semplice
- Con beneficio di inventario
Può essere fatta solo presso un Notaio.
La rinuncia può avvenire solo espressamente, dinanzi ad un Notaio o presso il cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.
Il termine per accettare o rinunciare all’eredità si prescrive in 10 anni.
Coloro che sono “chiamati ulteriori” rispetto ai primi successibili possono fare l’actio interrogatoria per far accettare o rinunciare i primi chiamati e poter esercitare il loro diritto in subordine.
Accettata ed acquistata l’eredità, il patrimonio avrà un nuovo titolare.
4) La quarta fase è rappresentata dalla COMUNIONE EREDITARIA (v. Comunione ereditaria).
Si ha comunione ereditaria quando al defunto succedono più eredi, i quali diventano comproprietari dei beni che fanno parte dell’eredità.
Dunque, se nel patrimonio ereditario subentrano più eredi (ad esempio i figli ed il coniuge), ciascuno dei coeredi diventa contitolare, in proporzione alla sua quota, dei beni appartenenti all’asse ereditario, dando origine a una comunione ereditaria.
Si pensi, ad esempio, ad un appartamento o ad una somma su un conto corrente lasciati a due figli e al coniuge: ognuno riceverà, in comunione, una percentuale dell’asse ereditario.
Trattasi di una fase eventuale, in quanto si instaura solo laddove vi siano più successori e può essere evitata in caso di testamento.
Laddove la successione sia regolata da un testamento e non dalla legge, infatti, è ben possibile, che il testatore decida di intervenire egli stesso nella divisione, attuandola direttamente per testamento.
In tal caso non si instaura lo stato di comunione ereditaria se non per un istante logico e cronologico nel momento dell’apertura della successione, ma operando la divisione essa si scioglie immediatamente.
5) L’ultima fase del fenomeno successorio è quella della DIVISIONE EREDITARIA (v. Divisione ereditaria).
Anche in tal caso può trattarsi di una fase meramente eventuale.
Gli eredi potrebbero, infatti, decidere di conservare lo stato di comunione sui beni, per i più vari motivi.
Laddove decidano invece di conseguire ciascuno la proprietà esclusiva per quanto di propria spettanza ci sarà questa operazione successiva.
La comunione ereditaria necessiterà di un successivo atto di divisione tra gli eredi, in cui si convengano le reciproche assegnazioni in piena ed esclusiva proprietà di ogni singolo bene facente parte della comunione.
La divisione ereditaria è l’atto con il quale si scioglie la comunione ereditaria, che sorge nel caso in cui vi siano più eredi del patrimonio del defunto.
Con la divisione i coeredi pongono fine alla comunione ereditaria e diventano unici proprietari dei beni che gli verranno assegnati.