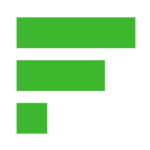(v. Realtà relazionali)
Riferimenti normativi
Articolo 1 commi 36 e ss. L. n. 76/2016
Disciplina
Occorre preliminarmente chiarire che per convivenza si possono intendere due diverse fattispecie:
1) la “convivenza di fatto” registrata all’Anagrafe (tra persone di sesso identico o di sesso diverso), come tipizzata dalla legge nel 2016;
2) la convivenza di fatto non registrata c.d. “more uxorio” (che, nella nuova legge, non trova menzione, ma è frutto di prassi e consuetudine.
Per convivenza di fatto si intende la condizione di “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
A partire dagli anni novanta il fenomeno delle convivenze “more uxorio” si è diffuso a dismisura, tanto che si è fatta sempre più pressante l’esigenza di regolamentare i rapporti personali patrimoniali e successori tra persone conviventi legate da un vincolo affettivo stabile.
La legge sulle convivenze di fatto nasce, infatti, dal bisogno di tipizzare i diritti dei conviventi.
Il fenomeno in verità era già da prima stato ampiamente affrontato da dottrina e giurisprudenza che hanno elaborato, pur in assenza di riferimenti normativi, un valido sistema di tutele, prima fra tutte la ripetizione dell’indebito in caso di separazione.
L’obbligo di reciproca assistenza materiale tra conviventi è stato inquadrato da dottrina e giurisprudenza nell’ambito delle obbligazioni naturali (v. Obbligazioni naturali).
Le convivenze “more uxorio” non registrate continuano a restare fuori dal perimetro applicativo della legge del 2016. Le coppie possono, pertanto, liberamente decidere di instaurare il proprio rapporto di convivenza prescindendo da alcuna tipizzazione giuridica.
A differenza del matrimonio (v. Matrimonio) e delle unioni civili (v. Unioni civili), la convivenza di fatto è ammessa sia tra persone di sesso diverso che tra persone dello stesso sesso.
Elemento essenziale è che vi sia uno stabile legame affettivo.
Quanto alle modalità di costituzione della convivenza, la legge, per l’instaurazione di un regime di convivenza di fatto registrata, richiede una dichiarazione anagrafica. L’accertamento della stabile convivenza richiama l’art. 4 e l’art. 13 co. 1 lett. b) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante il “Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”. I conviventi, dunque, per accedere alla normativa di cui alla L. 76/2016 devono presentare una dichiarazione anagrafica.
La specialità del fenomeno della convivenza rende necessario analizzare gli aspetti personale, patrimoniale e successorio che contraddistinguono la fattispecie.
Dal punto di vista del rapporto personale sono riconosciuti al convivente tre fondamentali diritti:
– Il diritto di visita in caso di malattia o ricovero di uno dei due conviventi, nonché il diritto di accedere alle informazioni personali, alla stessa stregua del coniuge o di un familiare;
– Il diritto di designare l’altro convivente quale proprio rappresentante, attraverso un atto da redigersi in forma scritta ed autografa o, in alternativa, alla presenza di un testimone.
In tali ipotesi il convivente designato potrà prendere sia decisioni in materia di salute, nel caso in cui l’altro sia affetto da una malattia che comporta incapacità d’intendere e di volere, sia decisioni in materia di donazioni di organi, modalità di trattamento del corpo e celebrazioni funerarie per il caso che l’altro muoia (v. Testamento biologico);
– Il diritto di nominare il proprio convivente quale proprio tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora si versi in stato di interdizione, inabilitazione ovvero ricorrano i presupposti di cui all’articolo 404 del Codice civile.
Il diritto di designare l’altro convivente quale rappresentante anche in materia di scelte attinenti alla salute è peraltro stato recentemente oggetto di disciplina con le “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.
E’ stato infatti introdotto per la prima volta in Italia il c.d. testamento biologico. La legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, prevede all’articolo 4, che ogni persona capace d’intendere e di volere può – in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi – esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché prestare il proprio consenso o rifiuto rispetto a determinati trattamenti sanitari attraverso le disposizioni anticipate di trattamento (c.d. D.A.T.).
Egli può altresì nominare sempre attraverso le D.A.T. una persona di propria fiducia (che può essere anche il convivente) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario nominato deve accettare la nomina sottoscrivendo le D.A.T. in presenza del notaio rogante, e la sua nomina può in ogni momento essere revocata dal disponente, senza obbligo di motivazione e con le stesse modalità previste per la nomina (atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro).
Ulteriore aspetto fondamentale e del tutto innovativo rispetto al passato, è che tali D.A.T. sono vincolanti per il medico curante, il quale può disattenderle solo in casi particolari e con il consenso del fiduciario. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali viene in rilievo, in primo luogo, la figura del contratto di convivenza: uno schema atipico al quale ricorrere per regolare i rapporti patrimoniali fra conviventi (v. Contratto di convivenza).
Fuori dall’ambito del contratto di convivenza, la legge del 2016 riconosce al convivente di fatto tre fondamentali diritti patrimoniali:
– Il diritto ad esser preferiti nelle graduatorie per l’assegnazione delle case popolari, nell’ipotesi in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza;
– Il diritto di lavorare nell’azienda familiare dell’altro convivente (v. Impresa familiare), partecipando così agli utili ed agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in misura proporzionale alla qualità e alla quantità del lavoro svolto.
Questa grandissima novità è attestata dal nuovo articolo 230 ter del Codice civile, introdotto dal co. 46 della riforma, al fine di rispondere alla (ingiusta) inestensibilità della disciplina di cui all’articolo 230 bis del Codice al convivente more uxorio, come sancita dalla Corte di cassazione.
Tutt’al più la giurisprudenza riconosceva al convivente il rimedio dell’arricchimento senza causa, considerando in ogni caso le prestazioni lavorative del convivente nell’azienda familiare come effettuate per motivi affettivi e come tali caratterizzate dalla gratuità.
Al convivente partecipante non è espressamente riconosciuto il diritto di prelazione per il caso in cui si decida di dividere o trasferire l’azienda familiare, ma si ritiene comunque sussistente; prelazione che viceversa è espressamente prevista per gli altri partecipanti.
– Il diritto a ricevere il risarcimento del danno nel caso in cui l’altro convivente muoia per una causa derivante da fatto illecito compiuto da terzi.